Di nuovo cambio casa
Traslochi
Dopo dodici anni, ho deciso di riunire i miei blog (quattro sono troppi ) sotto un unico profilo, utilizzando la piattaforma wordpress. Spero possiate continuare a seguirmi. Grazie
Traslochi
Dopo dodici anni, ho deciso di riunire i miei blog (quattro sono troppi ) sotto un unico profilo, utilizzando la piattaforma wordpress. Spero possiate continuare a seguirmi. Grazie
Gli occhi della donna dai capelli rossi si erano piantati nella mente di Ferruccio. Non sapeva se quella giovane irlandese, sempre insieme a quei due ragazzini, si trovasse quotidianamente davanti ai cancelli del mattatoio solo per cercare cibo o per rimproverare, con la sua presenza silenziosa, il suo involontario delitto. Il giovane italiano si era fatto convinto che lo sguardo della donna nascondesse la verità che egli era aveva provato a cancellare dal suo animo. Era come se fissandolo con quegli occhi verdi, la irlandese gli dicesse: “So che sei andato sul ring per eliminare il tuo avversario”. Iniziò a maturare in lui un senso di colpa che Ferruccio tentava invano di scacciare , lavorando come una bestia da soma. Il pensiero e la colpa per ciò che aveva fatto sembravano quasi scomparire nel rumore assordante del suo respiro affannoso, quando caricava i quarti di bue sui carri o quando spingeva le vacche nel mattatoio. Ma tutto si annullava nel momento in cui quella donna e i suoi ragazzini, apparivano davanti alle inferriate. Ferruccio tentava di nascondersi, non voleva che la donna lo scorgesse, aveva iniziato ad avere terrore di non poter reggere il suo sguardo. Di notte non dormiva più. Spesso sognava di essere ancora sul ring e Paddy gli appariva steso, al tappeto, nell’ultimo rantolo della morte. Non poteva resistere più a lungo. Una febbre invisibile agli altri lo stava consumando. Era visibilmente dimagrito, nonostante continuasse a lavorare come prima e più forte di prima. Nessuno conosceva il motivo del suo malessere e nessuno sembrava aver notato i suoi cambiamenti profondi, nessuno tranne Donato Mastrobuono. Il boss di Ferruccio aveva assistito all’incontro e alla disperazione del ragazzo quando aveva capito che quella donna era la moglie del suo amico Paddy. Era preoccupato, per lui Ferruccio era diventato come il figlio che non aveva mai avuto e non voleva che l’incidente avuto sul ring, condizionasse la sua vita. Fu proprio lui a soccorrere Ferruccio quella mattina. Il giovane italiano stava lavorando con una strana foga quel giorno. Donato lo aveva notato e aveva anche visto che la moglie e i figli di Paddy erano già nei pressi del cancello. La donna seguiva tutti i movimenti di Ferruccio e l’italiano tentava di nascondere il volto dietro quei pezzi di carne che caricava senza sosta da oltre quattro ore. “Non devo guardare, non devo guardare” diceva l’italiano a sé stesso. Proprio mentre gli stavano calando un quarto di bue sulle spalle, Ferruccio si era girato per vedere se la donna stesse ancora lì ma questa volta gli occhi della bella irlandese sembrarono due fanali accecanti sotto i riflessi del sole cocente di mezzogiorno: Ferruccio fu come ipnotizzato, di colpo si fece buio, sentì le gambe cedere, tentò di resistere, barcollò e il peso dell’animale morto lo buttò a terra. Cadde malamente. Tentò di rialzarsi mentre i suoi compagni di lavoro accorrevano per sorreggerlo Si trascinò dondolando, senza metà. Fino a quando stramazzò con un tonfo secco. Ferruccio rimase incosciente per un paio di giorni. Nel deliquio della sua febbre, le immagini si affastellavano vorticosamente: ora era sul ring, stava combattendo contro Paddy ma, nello sferzare pugni, si rendeva conto di colpire un fantasma. Altre immagini riguardavano gli occhi verdi della irlandese che lo fissavano dal bordo del ring mentre lui rimaneva dritto, immobile al capezzale di Paddy morente.

Si svegliò nel letto di un ospedale. La sua vista, inizialmente offuscata dal suo stato, prese coscienza lentamente della stanza nella quale si trovava, avvolta in una sorta di penombra soffocante. Si stava abituando alla semioscurità che lo circondava quando scorse una figura femminile, seduta, in un angolo, che pareva vegliarlo come una sentinella. Da principio non riuscì a scorgere il suo volto ma, quando ella si accorse che Ferruccio aveva ripreso conoscenza, si avvicinò accendendo la lampadina del comodino. Non poteva essere, la moglie di Paddy! Ferruccio fu scosso da un tremito come se l’incubo continuasse ancora, nonostante fosse ormai sveglio. La donna si chinò su Ferruccio, i suoi occhi ormai erano piantati in quelli dell’uomo. All’improvviso accadde qualcosa che l’italiano non si sarebbe mai aspettato: ella sorrise porgendogli un bicchiere d’acqua: “Ecco, bevi, ti sentirai meglio”. Avrebbe potuto sembrare un gesto stupido ma in quel bicchiere che ora l’italiano teneva stretto dalle mani della donna , sorseggiando con avidità, era racchiuso un balsamo per l’anima di Ferruccio. Tentò di pronunciare qualche parola ma lei lo interruppe: “Non dire nulla, non adesso”.
…Mastro Cenzino non era il solo ad avere covato un sentimento di vendetta verso U’bestiu. In famiglia c’era un’altra persona che considerava Nicola, un individuo capace di intralciare i suoi progetti di arricchimento ai danni dei cutrunesi: questa persona era Costantina, la giovane moglie di Mastro Cenzino. La donna non era originaria del paese e si diceva fosse stata conosciuta da l’uomo, nei ricorrenti viaggi che questi faceva in città. Poco si sapeva delle sue origini ma i più smaliziati asserivano che la ragazza avesse lavorato in un casino e che Mastro Cenzino, ammaliato dalle sue doti amorose, avesse deciso di portarla via da quell’ambiente per restituirla ad una vita da signora. Costantina era ambiziosa e aveva visto in Mastro Cenzino la possibilità di riscattarsi dalla miseria, diventando una signora rispettabile. Attentissima alle finanze e gli affari del marito, in poco tempo era divenuta sua consigliera tanto che Mastro Cenzino non intraprendeva nessuna attività se non prima di aver consultato la moglie.

Il marito era stato stregato a tal punto che Costantina avrebbe potuto chiedergli qualsiasi cosa, persino un omicidio. Andava matta per i gioielli e specialmente gli zaffiri che si faceva incastonare in collane ed anelli ostentati in modo quasi sconveniente durante le domeniche a messa o le festività. Le donne del paese, forse perché invidiose, l’avevano soprannominata “la Zaffira”. Nonostante fosse ormai la moglie di Mastro Cenzino e vestisse in abiti che si addicevano a quelli di consorte dell’uomo più importante del paese, rimaneva in lei una bellezza sensuale la quale ancora traspariva dai suoi profondi occhi neri e dalle forme procaci del suo corpo malamente celate da vestiti attillati, come se la sua passata professione l’avesse abituata ad essere naturalmente provocante. La Zaffira ancheggiava sicura per le strade di Cutruni senza temere minimamente di essere disturbata ma sotto l’ombra della coppola degli uomini che se la vedevano passare sotto il naso, il mormorio dei commenti era simile al ronzio di un favo di api rimosso per sbaglio. La Zaffira conosceva la storia di U’bestiu nella versione che il marito aveva dato di quella e in lei, era maturato con gli anni, una sorta di odio più vicino alla curiosità morbosa, come se Nicola, con i suoi comportamenti ribelli, confrontato con le opere e gli intrallazzi del marito, ne uscisse vincitore per la sua umanità rispetto a l’i
La Zaffira, con gli anni, si era convinta che il suo passato fosse stato definitivamente sepolto dal matrimonio e dalla riservatezza che solo un paese come Cutruni avrebbe potuto dare, quand’ecco che gli antichi fantasmi si riaffacciarono terribili a tirare le vesti della Zaffira. Il suo desiderio di cambiare vita, fuggendo dalla menzogna del postribolo aveva portato la Zaffira a mentire a Mastro Cenzino riguardo la sua libertà nel lasciare quel posto di lavoro, Ella era invece fuggita senza dir nulla, portando con se l’incasso sottratto alla tenutaria in un attimo di distrazione. Subito gli scagnozzi al soldo della megera si erano messi sulle tracce della fuggitiva ma avevano dovuto rinunciare perché di lei si era perso ogni indizio che potesse condurre alla sua persona. Tuttavia, con gli anni, Mastro Cenzino, stufo della moglie, aveva intensificato suoi viaggi in città, andando nuovamente a frequentare i bordelli in cerca di carne fresca. I vecchi tenutari del casino dal quale era fuggita Zaffira, lo avevano riconosciuto e ci avevano messo poco a realizzare dove fosse andata a finire la donna. La Zaffira era rimasta impietrita quando gli emissari della vecchia tenutaria le si erano presenti alla porta, dopo aver accertato che Mastro Cenzino fosse in città per affari: “ Allora, sgualdrinella, ci rivediamo?” “La Zaffira aveva tentato di replicare qualcosa ma la sua bocca era serata da un muto terrore. I tre omaccioni la presero per il collo e la sbatterono dentro casa, serrando la porta.
Ferruccio non fu mai perdonato dagli irlandesi per quella morte. Lui non voleva uccidere Paddy ma sapeva, in cuor suo, che avrebbe potuto evitare, di essere così spietato durante l’incontro. Forse lo aveva fatto per il premio o perché in quell’amico che lo affrontava, aveva visto il volto di un essere misero come lui, pieno di quella povertà che lui avrebbe voluto scacciare con i suoi pugni. Giurò che non avrebbe più combattuto. I fratelli Mastrobuono, sebbene soffrissero per quella decisione, perché Ferruccio era un talento, compresero il dolore che il ragazzo portava dentro di sé. Ferruccio si gettò a capofitto nel lavoro quasi a volersi stordire per non ricordare quello che era accaduto. Nei mesi che seguirono spesso gli altri operai, arrivavano al lavoro che già Ferruccio era lì dall’alba e se ne andavano che stava ancora nel mattatoio a contare le bestie. I fratelli Mastrobuono potevano chiedere di tutto al giovane tranne una cosa: macellare gli agnelli. Ferruccio non ce la faceva. Ogni volta che un carico di pecore con i loro agnellini arrivava in mattatoio destinato alla macellazione, Ferruccio non resisteva. Nella sua testa, i belati dei piccini separati dalle loro madri che rispondevano ai loro lamenti come fossero coscienti del destino atroce che li attendeva, si piantavano nelle orecchie di Ferruccio come un chiodo.
Quello che lo tormentava era lo sguardo di terrore che trasformava le pupille di quelle creature. Ferruccio si sentiva soffocare e doveva allontanarsi da qualche parte per vomitare anche quello che non aveva mangiato. Fu durante uno di quei carichi nei quali il recinto della ditta era affollato da un gregge in cerca di vie di fuga che Ferruccio si accorse della presenza di due bambini, fuori dallo steccato che osservavano gli agnellini con gli occhi lucidi. Erano un maschietto e una ragazzina che gli stringeva la mano. Dai lineamenti avrebbero potuto essere fratello e sorella. Quello che Ferruccio notò furono i loro capelli, color del rame. Nei tratti dei loro volti, negli occhi verdi, il giovane italiano scorse una somiglianza con qualcuno che lui conosceva bene. Erano lì, con lo sguardo di chi avrebbe volentieri portato a casa uno di quei cuccioli quando una donna, da l’aspetto fiero, ma dagli abiti miseri, si avvicinò a loro e li esortò a sbrigarsi. Ferruccio rimase colpito dalla sua bellezza, avrebbe voluto avvicinarla, sorriderle ma le sue intenzioni persero ogni forza nel momento in cui ella, accortasi che Ferruccio la stava osservando, ricambiò il suo sguardo con una espressione carica di odio profondo. L’italiano si sentì a disagio e rientrò nel capannone. Le visite dei due ragazzini continuarono nelle settimane seguenti e ogni volta la donna si affrettava a ricondurli a sé, nel momento in cui Ferruccio tentava di avvicinarsi. Notò degli strani movimenti da parte della giovane dai capelli rossi, specialmente durante l’ora di pausa degli operai. La donna spesso si avvicinava alla recinzione oltre la quale il gruppo degli irlandesi mangiava il proprio pasto; dal gruppo si alzava l’operaio con il quale Ferruccio si era attaccato qualche anno prima e consegnava alla donna un involucro voluminoso. Ferruccio comprese che in quel cartoccio avrebbero potuto esserci scarti di mattatoio, di quelli che no si danno neanche ai cani. Immaginò la ragazza rientrare subito a casa, magari una catapecchia, per cucinare quella roba in una brodaglia con l’illusione di dare un po’ di nutrimento a quei due ragazzi. Gli occhi della donna gli si piantarono nella mente. Non sarebbe stato capace di dirle una parola ma sapeva che doveva esserci qualcosa, di strano e terribile, in quello sguardo che aveva incrociato per qualche attimo. Era ne l’ufficio dei Mastrobuono una mattina, verso l’ora di pranzo, perché Steve Centofanti era venuto per salutarlo e per parlare con i Mastrobuono. “Ci manchi, ragazzo – disse Steve – saresti potuto diventare qualcuno nella boxe” Ferruccio sorrise malamente quasi che quelle frasi gli avessero riportato alla mente la sera della disgrazia. Mastrobuono intuì quello che si celava nel cuore del ragazzo ma che non poteva esprimere per riverenza verso il suo datore di lavoro “Lo so, quello che è successo ti ha ferito ma tu non ne hai colpa”. La vita è matrigna. “Guarda quella povera donna – disse Mastrobuono indicando fuori dalla finestra: Ferruccio si girò verso la rete e accennò ad un’espressione di sorpresa, davanti c’era la ragazza con i capelli rossi e i suoi due figlioli – non ha più niente da mangiare da quando il marito Paddy ci è rimasto sul ring “– riprese Mastrobuono. Ferruccio sentì il sangue gelarsi nelle vene: quella la moglie dio Paddy? Comprese il perché di quella presenza costante, di quegli sguardi rivolti a lui. Si sentì un verme. Era per colpa sua se quei tre poveri disgraziati erano rimasti senza un padre e un marito. Uscì senza dire un parola.

…Padre Girolamo era stato mandato a Cutruni, agli inizi dell’ottocento, dalla lontana Predazzo, nel tentativo di catechizzare i poveri abitanti del paese, stretti tra il giogo dei Borboni e le prebende dello Stato Pontificio. Era un uomo levato ai masi dalla famiglia numerosa la quale non avrebbe potuto sfamare un secondogenito e mandato in seminario affinchè la religione gli cadesse da l’alto come una randellata per tappargli il buco che aveva nello stomaco e sotto le scarpe. Padre Girolamo era uomo di montagna con la segreta passione per la musica e . La famiglia non aveva soldi per compragli uno strumento, così Padre Girolamo da giovane, era andato a bottega da un falegname che gli aveva insegnato come costruire un violino e suonarlo. In verità il suo maestro, benchè dotato di generosità verso il fanciullo, difettava nella pratica dello strumento e il giovane si era trovato a suonicchiare semplici melodie strappalacrime che non sarebbero servite neanche a conquistare la pastorella meno ambita. Al seminario era riuscito a migliorare la sua tecnica grazie a un prete più anziano con la mania per Bach. Una volta presi i voti e arrivato a Cutruni, aveva portato la melodia di quel violino che riempiva di note il momento dei vespri oppure rallegrava un modesto matrimonio di campagna fino a celebrare degnamente il funerale di qualche bifolco. Nel periodo della sua permanenza aveva dato anche lezioni di musica a qualche chierichetto che avesse avuto un ritaglio di tempo dal lavoro nei campi. Il prete prediligeva lunghe passeggiate nei boschi che circondavano Cutruni, escursioni nelle quali raccoglieva piante medicinali e passava momenti di meditazione seduto sotto i grandi e severi alberi della foresta. Una trentina di anni dopo che se ne fu andato, si scoprì che Padre Girolamo aveva lasciato molto di più di quello che aveva preso: i contadini che andavano a fare legna narrarono che una piccola foresta di abeti stava crescendo al fianco del bosco dal quale si approvvigionavano per l’inverno, erano abeti rossi. Non solo questo: Padre Girolamo si costruiva da sé i suoi violini utilizzando quel legno che per i Cutrunesi non aveva altra funzione se non quella di finire dentro al fuoco. Fu così che questo piccolo bosco di alberi “stranieri” venne ribattezzato: “Bosco di Padre Girolamo” e i suoi abeti “ Alberu ca’ sona”. Tra i chierichetti c’era stato anche Giustino, figlio dell’unico falegname del paese al quale Padre Girolamo, otre ad aver insegnato a suonare il violino, aveva lasciato tutta la sua collezione di strumenti alcuni dei quali il ragazzo di bottega, si era affrettato a smontare per vedere “come funzionavano”. Giustino il quale, sembrava una zucca tosta ma era invece un giovane molto laborioso, si era dato da fare per rimontare quello che aveva fatto a pezzi. Non riuscendo ne l’impresa, per non disonorare la memoria di Padre Girolamo, aveva pensato di costruire un violino di sana pianta. La cosa gli era riuscita in modo sufficiente e, con il passare degli anni e l’eredità lasciata nel bosco da Padre Girolamo, era arrivato, ormai anziano, ad essere un liutaio rinomato anche perché l’unico nel raggio di centinaia di chilometri. I violini di Cutruni erano rinomati e molti maestri di conservatorio salivano con fatica al paesello, per farsi confezionare uno strumento a seconda delle loro esigenze. La foresta di abeti rossi stava lì da quasi cent’anni, come uno straniero in terra straniera che avesse trovato una nuova patria. A tutti i Cutrunesi questa piccola fetta di notorietà faceva piacere anche perché spesso si organizzavano concertini nella povera piazza del paese. Il suono del violino sembrava spazzare via , per qualche momento, povertà e grettezza. Tutti erano contenti, tranne uno: Mastro Cenzino il quale vedeva in quella foresta la possibilità che quello spazio, arbitrariamente occupato dagli “alberi ca’sonano” potesse essere occupato dal cemento di qualche albergo, ovviamente costruito da lui, al fine di ospitare forestieri. Molte volte in consiglio comunale aveva espresso la perplessità sul fatto che quel bosco avrebbe potuto dare beneficio alla cittadina e i malumori dei cutrunesi nei suoi confronti erano attutiti dal fatto che Mastro Cenzino incuteva molto timore tra i villici. L’altro ostacolo era costituito da una persona che quei boschi li abitava da sempre: U’bestiu.

Ferruccio iniziò a frequentare la palestra di Steve Centofanti sempre più assiduamente. Finito il lavoro presso la macelleria, correva a prendere l’ultimo tram che lo conduceva nel quartiere di North End dove si poteva allenare fino a tardi sotto la supervisione del vecchio Steve. Il quartiere era pieno d’irlandesi e gli scontri con gli italiani erano all’ordine del giorno specialmente in palestra. A volte capitava che i match di allenamento tra due pugili si trasformassero in risse violente tra popoli diversi. Nonostante tutto Ferruccio, a parte la lite avuta con Zoot, sembrava non farsi problemi con gli irlandesi. Fu così che strinse amicizia con uno di loro, Paddy Ryan, un pugile che aveva avuto già qualche esperienza in match ufficiali e lavorava come muratore per mantenere la moglie Loreena e i suoi quattro figli: “Ferruccio, i soldi della borsa non mi bastano”. I match, agli sconosciuti li pagano poco. Lo faccio perché voglio che i miei figli crescano con un’istruzione. In Irlanda badavo alle pecore. Sapevo di dover lavorare duramente ma non fino a questo punto”. Ferruccio guardava quel giovane pieno di speranza e pensava che ognuno nel mondo avesse avuto un agnello da sacrificare per sopravvivere. Vedeva negli occhi di Paddy, lo stesso suo sguardo che s’illuminava ad immaginare le colline e i monti del suo paese e le braccia di un pastore disperato tese contro il cielo a maledire gli dei delle foreste per ogni agnello sacrificato. Si allenavano con impegno e Ferruccio, dopo qualche mese, ebbe i suoi primi incontri ufficiali. Le vittorie arrivarono facilmente. I fratelli Mastrobuono lo avevano preso in simpatia e spesso, quando doveva combattere in qualche città vicina, non gli negavano il permesso di assentarsi per qualche giorno dal lavoro. C’era da dire che contavano molto sul ragazzo anche perché Rosario era un amante delle scommesse e il fatto di puntare su Ferruccio vincente gli assicurava molto più denaro di quanto ne avrebbe potuto guadagnare con il lavoro del ragazzo in macelleria. Paddy e Ferruccio sapevano che alla fine avrebbero combattuto l’uno contro l’altro. Accadde la settimana di Natale. L’incontro ebbe luogo in un palazzetto adibito alla boxe nel West End. Ferruccio era stranamente nervoso, l’idea di combattere contro un amico non gli piaceva ma la borsa messa in palio era abbastanza cospicua e consisteva in un’automobile. In sala non c’erano molti spettatori anche perché non si trattava di pugili molto quotati. Il pubblico era composto prevalentemente da operai, qualche allibratore e un paio di gangster di quartiere, pronti a bruciare i loro soldi nelle scommesse a bordo ring. Ferruccio e Paddy salirono sul ring. Nonostante l’irlandese guardasse l’italiano con l’aria di chi sapeva che di fronte non avrebbe avuto un nemico ma un fratello che avrebbe tentato di fargli meno male possibile, Ferruccio aveva ancora addosso la sensazione strana che lo aveva accompagnato sin dal momento in cui aveva saputo dell’incontro. Non osava guardare Paddy come se volesse cancellare dalla sua mente ogni forma di rimorso per i colpi che di lì a poco gli avrebbe inferto. Il match prese subito una piega inattesa. I pugni di Ferruccio si fecero pesanti. Paddy percepì, nel procedere del match, che l’italiano era venuto lì per vincere a tutti i costi. Ferruccio sembrava animato da una strana energia e l’immagine del suo amico iniziava a sfocarsi per assumere quella di un nemico dai contorni non ben disegnati, il quale doveva essere abbattuto. L’uomo di fronte a lui non era più il ragazzo con il quale aveva stretto un patto nella miseria, ma era un ostacolo, una forza esterna a lui che gli avrebbe impedito di sopravvivere. Ferruccio sferrava colpi e intanto sentiva l’avversario cedere lentamente sotto i suoi pugni. Paddy era ormai scomparso. Nella sospensione della sua coscienza, Ferruccio si ritrovò immerso nella grandinata tra le sue montagne: il suo sudore era l’acqua che scorreva copiosa sul suo volto, mentre lui si affannava, roteando le braccia per evitare i chicchi ghiacciati che scendevano dalle nubi scure. Ferruccio correva a salvare le sue pecore rimaste sotto gli elementi, disperse in preda alla paura, precipitate negli orridi, lungo i pendii scoscesi della montagna. Nella gragnuola dei colpi che sferrava alla tempesta, s’illuse di averne salvata una e la teneva ferma a terra, per evitare che anche questa sua ultima si gettasse dalla rupe. Fu allora che fissò i suoi occhi sullo sguardo dell’agnello terrorizzato, che si dimenava tentando di fuggire. Ferruccio uscì dalla trance nella quale era caduto: ai suoi piedi, al posto dell’animale. Paddy giaceva inerme mentre, intorno a l’irlandese, una folla impietrita guardava il dottore ne l’atto di rianimare il ragazzo. Gli occhi di Paddy erano sbarrati. Durò poco: il medico posò una mano pietosa sulle sue palpebre e le abbassò. Tutti guardarono Ferruccio senza proferire una parola. Paddy era morto e lui lo aveva ucciso con i suoi pugni…

…Mastro Cenzino decise di accomodarsi con i suoi accompagnatori per passare la notte lì. Il primo turno di guardia toccò al più giovane che lo aveva accompagnato. Cenzino e l’altro scagnozzo si addormentarono vicino al fuoco. La notte era silenziosa e non ci misero molto a prender sonno. Dopo un paio d’ore Mastro Cenzino fu svegliato da un ticchettio insistente, sembrava il rumore lontano di qualcuno che stesse sbattendo due pietre focaie, l’una contro l’altra. “Giovà!” Chiamò l’uomo di guardia per assicurarsi che tutto procedeva liscio ma non ebbe risposta. Cenzino e l’altro uomo si alzarono continuando a chiamare la sentinella. Giovanni pareva essere scomparso. Fecero un giro di perlustrazione quando Cenzino inciampò in qualcosa lasciato lì tra le rocce: erano il fucile di Giovanni e i suoi stivali. Udì un fruscio sulla sua testa e alzò lo sguardo: la sentinella pendeva a testa in giù da una grossa quercia. Il ragazzo era legato per i piedi e un bavaglio gli impediva di chiedere aiuto. Mastro Cenzino tentò di liberarlo chiamando a gran voce lo scagnozzo più anziano. Per tutta risposta un urlo riempì la vallata. Cenzino accorse per vedere cosa fosse accaduto ma anche l’altro uomo era scomparso. Il mastro iniziò ad avere paura. Non aveva possibilità di liberare Giovanni perché se avesse tagliato la corda, questi sarebbe caduto malamente e aveva perso anche il secondo accompagnatore. Fino il mattino rimase a vegliare il ragazzo a testa in giù. Fu colto da un senso di rabbia e impotenza e questo accrebbe il suo desiderio di risolvere la questione del ruscello. Ormai aveva capito che era opera di U’ubestiu e il suo odio per quest’uomo si era moltiplicato poichè si era fatto beffe dei suoi uomini così facilmente. Avrebbe potuto uccidere anche lui se avesse voluto, a questo Mastro Cenzino aveva pensato e questo rendeva Nicola un uomo da eliminare a tutti i costi perché era un avversario temibile, il quale non si sarebbe accontentato di una semplice vendetta. Decise di sciogliere Giovanni a qualsiasi costo. L’uomo, una volta tagliata la corda che lo teneva appeso, cadde come un sacco di patate. Mastro Cenzino si rese subito conto che non gli sarebbe stato d’aiuto e lo lasciò lì a riprendersi per poterlo trovare rinfrancato al suo ritorno. Cenzino continuò a salire il pendio roccioso seguendo il corso del fiumiciattolo. Ci vollero tre ore prima di arrivare al punto nel quale, il torrente compiva un salto di una ventina di metri, cadendo da una stretta gola. Fino a quel momento Mastro Cenzino aveva proceduto con estrema cautela, tenendo il fucile sempre in mano e osservando i pendii circostanti. Anche lì, il letto del fiume sembrava stranamente asciutto, solo un piccolo rigagnolo simboleggiava l’esistenza di un corso d’acqua. Mastro Cenzino, arrivato ai piedi del luogo nel quale avrebbe dovuto esserci la cascata, comprese cosa era accaduto: una frana aveva ostruito completamente il corso del torrente. Mastro Cenzino trovò subito le tracce di quello che era stato il luogo nel quale U’ubestiu aveva preparato la miccia per l’esplosione. Rimase impietrito quando, tra le rocce che occludevano il passaggio dell’acqua, scorse il suo secondo accompagnatore, legato come un salame. L’uomo si dimenava quasi a voler dissuadere Mastro Cenzino perché non si avvicinasse. Intorno al suo corpo, una miccia lunghissima era stata accesa. Il filo terminava dentro una cassetta sulla quale era seduto lo scagnozzo. Mastro Cenzino era paralizzato. La miccia si bruciava velocemente e Cenzino corse subito al basto del suo cavallo per cacciare il coltello ma non trovò nulla, U’ubestiu si era appropriato di tutto: fucili, coltelli, corde. Intanto la miccia bruciava e l’unico modo per liberare il suo uomo sarebbe stato quello di usare le mani o i denti. Doveva srotolare la miccia che avvolgeva lo scagnozzo, per poi slegarlo e fuggire con lui in un posto riparato onde non essere travolto da l’esplosione. L’operazione fu rischiosa e la miccia era quasi arrivata alla cassetta quando Mastro Cenzino riuscì nel tentativo. Si girò per correre verso il suo cavallo ma anche questi era sparito nel nulla. I due uomini si gettarono a terra. L’esplosione liberò nuovamente il corso del fiume e i due furono trascinati dalla corrente per diversi metri prima di poter mettersi in salvo. “Questa volta ti è andata bene” Gridò U’ubestiu dal folto della boscaglia “ma ricordati che sei appeso a un filo e quando penserai di essere al sicuro, quel filo io verrò a farlo dondolare ogni tanto.” La voce scomparve travolta dal rumore delle acque che scorrevano di nuovo.

“Ferruccio, vieni in ufficio che ti devo parlare”. La voce di Donato Mastrobuono risuonò alle spalle del ragazzo. Ferruccio si spaventò, credendo che i fatti accaduti il giorno prima con l’irlandese potessero avere ripercussioni sul lavoro. Gli stranieri, una volta arrivati negli Usa, dovevano rigare dritto, almeno per i primi tempi. Non era difficile che qualche connazionale ritornasse nel paese di miseria dal quale era partito, con un foglio di via e il consiglio di non tornare più in America, se era stato coinvolto in qualche guaio, anche piccolo. Ferruccio si presentò da Mastrobuono, tenendo stretto il cappello tra le mani, con l’aria di chi si aspetta qualche lavata di capo. “ Uagliò tu picchi duro!” Donato accennò ad un piccolo sorriso che subito spense, perchè il giovane non pensasse di aver fatto un bel gesto “Ma in questo posto non è cosa da farsi” continuò Mastrobuono “Gli irlandesi sono lavoratori come gli italiani e come agli italiani, ogni tanto gli va il sangue alla testa” Ferruccio ascoltava in silenzio “ Se vuoi continuare a lavorare qui, tu ti devi controllare…solo così puoi vincere sul ring” Il giovane non capiva “Senti Ferruccio, che ne diresti se ti faccio conoscere un amico mio, un allenatore, uno di quelli che ti può far guadagnare qualche extra, giusto per levarti qualche sfizio?” “Voi mi state chiedendo se sono interessato a fare a pugni, ma…” “Non ti preoccupare, tu prova – disse Donato. Se non ti piace tu ci hai sempre il lavoro assicurato qui da noi” Ferruccio annuì in silenzio “Domani dopo il lavoro ti accompagno io, ora va che c’è tanto da fare e non dare pretesto agli irlandesi che quelli adesso, se lo sono segnato al dito quello che hai fatto”.“Colpisci!” Ferruccio era davanti a quel sacco che pendeva dal soffitto, enorme. Steve Centofanti aveva messo due guantoni a quel ragazzo, i più consumati che aveva trovato, ma sempre troppo nuovi da destinare ad un bifolco appena sceso dalle montagne di Cutruni. Ferruccio guardò il sacco. A l’improvviso tirò indietro il braccio, morse il labbro, facendo partire il colpo. Il polso incerto, nel momento dell’impatto, gli fece piegare la mano che scivolò sulla pelle consunta del bersaglio. Il sacco accennò a una piccola vibrazione mentre Ferruccio si ficcò la mano dolorante sotto l’ascella. “Sei un fesso.” Centofanti sorrise. Ferruccio lo guardò accigliato. L’allenatore si ricompose. “Concentrati, piega le ginocchia, colpisci, ma ricorda di tenere il pugno allineato al polso.” Ferruccio aveva di nuovo lo sguardo sul sacco. Sembrarono degli attimi interminabili: colpire di nuovo, provare di nuovo dolore, incapacità? Possibile che un sacco potesse svelargli la sua debolezza? Li vedeva già, gli irlandesi ridere di lui mentre goffamente tentava di smuovere quel otre pieno di cattivi pensieri, di greggi morti, di montagne abitate dalla miseria, di stanze grigie e di bestemmie contro i quarti di bue. Centofanti guardò il collo del ragazzo irrigidirsi. Il sacco incombeva su Franco quasi come una vita troppo grande per quel ragazzino. Aveva gli occhi pieni di lacrime e sentiva la sua impotenza ammollargli le braccia, appesantirgli i polpacci. Poi, come una luce al termine di una galleria, emerse dal fondo della sua mente, un suono flebile, un lamento, la voce dell’agnello che chiedeva pietà al pastore, perché non lo sgozzasse, non gli facesse del male. Ferruccio fu stretto alle tempie da un calore sordo, un grido soffocato stava per tracimargli dalla gola. L’odio arrivò come una locomotiva, Ferruccio lo sentì salire fino alle spalle; le orecchie diventarono viola, una smorfia gli deformò il labbro e la guancia come l’effige di guerra di un dio pagano. Il braccio si contrasse. Il pugno partì. La mano affondò nel sacco che si spostò lentamente a l’indietro, dondolando. Ferruccio rimase fermo sulla sua posizione mentre il sacco tornava verso di lui. Rise. Rise anche Steve Centofanti.

…Mastro Cenzino tentò di dimenticare la notte nella quale U’ubestiu era arrivato in casa sua e gli aveva promesso vendetta. La guerra era finita e tutti erano contenti. Tornavano i reduci, le famiglie si ricomponevano e Cenzino aveva approfittato delle sue connivenze per arricchirsi, rubando le terre e i possedimenti a chi era troppo ignorante per poter far valere i propri diritti. Dapprima con i fascisti e poi con il comitato di liberazione, approfittando anche dell’eccidio, aveva avuto accesso alle carte comunali con l’incarico di reggente della comunità e aveva fatto sì che molti beni pubblici venissero alienati a suo favore. In particolare era riuscito a comprare a un prezzo irrisorio il mulino comunale al quale tutto il paese si rivolgeva per la macinatura del grano. Non ci volle molto per diventare sindaco. Bastò a Mastro Cenzino farsi vedere in chiesa molto più spesso di quanto non avesse mai fatto, per ottenere la simpatia di quelli che non vedevano di buon occhio i socialisti o addirittura i comunisti. In verità, Cenzino aveva sguinzagliato i suoi sgherri tra i pastori e i braccianti di Cutruni, promettendo tutto quel benessere che sembrava un sogno possibile dopo le miserie della guerra. In verità a quei bifolchi bastava che l’acqua e la luce entrassero nelle loro case e tutto sarebbe andato bene. A molti, abituati a prendere le botte dai padroni, la democrazia sembrava una cosa strana, difficile da capire. Avevano sempre avuto un prete che dicesse loro come fosse giusto lavorare e obbedire, senza lamentarsi perché il vero premio stava “nel regno dei cieli” così che il padrone era diventato il loro Dio il quale concedeva punizioni e pane. A chi si ribellava, perché vedeva il sacerdote spesso seduto a tavola con padrone, la risposta era quella della Bibbia e del peccato originale. Tutti questi poveri ignoranti non capivano per quale motivo la loro esistenza, provata dalla miseria, doveva svolgersi espiando la colpa di un peccato che non sapevano di aver commesso. Mastro Cenzino era lì perché loro avessero la loro giusta pena, lui era cosciente di tenere in pugno quella manica di poveracci ma la sua sicurezza iniziò a vacillare quando il fantasma de U’ubestiu ricomparve improvvisamente così come’era sparito. Fu una notte di primavera quando, da l’alto della montagna Malacosta che sovrastava il paese, si udì un boato fortissimo. La mattina dopo, il ruscello che alimentava l’immensa ruota del mulino di Mastro Cenzino, rimase a secco. Il mugnaio era disperato e nonostante non ne avesse colpa, Mastro Cenzino, una volta arrivato sul luogo dove la pala del mulino avrebbe dovuto accogliere la corrente d’acqua, iniziò a menare legnate sulla gobba dello sventurato, sotto gli occhi attoniti di tutti i cutrunesi che erano arrivati fino lì per farsi macinare il grano. Sembrava tutto così strano, eppure la Malacosta era carica di neve tanto che l’acqua sarebbe bastata fino a l’autunno successivo. Le fontane di Cutruni erano ricolme di quel liquido cristallino e nessuno aveva notato una discesa del livello nelle vasche degli abbeveratoi. Mastro Cenzino decise di salire, ripercorrendo il letto del fiumiciattolo, per capire dove fosse il problema. Poche persone conoscevano la zona e mai nessuno si era avventurato fino alle sorgenti del ruscello perché i cutrunesi sapevano che era zona de U’ubestiu così come anni prima credevano fosse il regno degli spiriti. L’impresa si presentò subito ardua, Mastro Cenzino procedeva a fatica, frustando il suo asino come fosse colpevole dell’accaduto. Era accompagnato da due scagnozzi con tanto di lupara a tracollo. Si fermarono per la notte dopo aver scollinato a l’altezza di un pianoro che introduceva alla parte più ripida della salita, quella nella quale il torrente cadeva a picco da due coste altissime di roccia grigia
Gli irlandesi avevano preso di mira Ferruccio. Il ragazzo aveva iniziato a lavorare da poco nel mattatoio dei Mastrobuono e la sua inesperienza talvolta lo rendeva goffo nei movimenti e impacciato quando si trattava di svolgere compiti che lui riteneva facili, dopo aver guardato i suoi colleghi i quali si muovevano agilmente, nonostante la durezza del lavoro. Talvolta i colleghi ridevano di lui quando lo sentivano imprecare in dialetto cutrunese, quasi a conferma dei loro pregiudizi sugli italiani. A questo si aggiungeva una sorta di nonnismo tra i lavoranti che prevedeva l’uso di costringere i nuovi arrivati a svolgere mansioni tra le più umili. Ferruccio non si lamentava e ogni volta che la mansione gli sembrava impossibile, subito la sua mente ritornava alla ruvidezza delle giornate invernali nelle quali era costretto a uscire per mungere le pecore o sorvegliare che gli ovili non fossero attaccati dai lupi. Era in quel momento che alzava gli occhi tra i capannoni del mattatoio quasi volesse scorgere quelle montagne dalle cui nevi traeva auspici per le primavere a venire. Nonostante fosse immerso in una vita che gli prometteva lavoro e un non ben precisato benessere, iniziò ad insinuarsi in lui il germe di una libertà che sembrava fosse stata naturale come l’aria da respirare quando aveva frequentato i pascoli natii ed ora gli appariva come una visione all’orizzonte velata da una foschia leggera. Questa sottile nostalgia talvolta gli oscurava l’animo e lo costringeva a lavorare con i nervi a fior di pelle specialmente quando coglieva la sottile aria di dileggio nei suoi confronti da parte del gruppo di nerboruti irlandesi addetti all’abbattimento del bestiame. Gli sberleffi e le offese andavano avanti da qualche tempo sotto l’occhio indifferente dei padroni i quali sapevano benissimo a cosa stesse andando incontro Ferruccio, perché avevano ricevuto lo stesso trattamento quando a loro volta erano stati emigranti e dipendenti. Ferruccio quella mattina ebbe il compito ingrato di ripulire le budella dei maiali, che servivano per fare salsicce. Lavorava da qualche ora in quella specie d, inferno caldo e maleodorante, tra i l puzzo delle feci e la soda quando Zoot, un pelo rosso alto e sdentato ebbe la malsana idea di arrivargli alle spalle per ornare in suo collo con un paio di metri di budella di porco appena squartato. Ferruccio si girò alle risa del gruppetto d’ irlandesi. Gli sembrò che un velo nero stesse scendendo sopra i suoi occhi quasi che la sua mente non dovesse vedere quello che il suo corpo avrebbe fatto. In un attimo si trovò a faccia a faccia con Zoot il quale si era già messo in guardia pronto a dare all’italiano una sonora lezione con le sue nocche. Ferruccio non aveva alcuna idea della boxe ma ricordava le zuffe da ragazzo, quando lui e Nicola si davano da fare per respingere gli assalti alle ragazze del loro paese da parte dei bifolchi o quando qualche ladro di pecore tentava di decimare i loro greggi. La rabbia gli scese dalle spalle fino ad arrivare ai suoi pugni e l’irlandese ebbe la sfortuna di assaggiare le mani di Ferruccio. Gli irlandesi ammutolirono: il loro compagno il quale pure aveva uno stile acquisito in qualche palestra dei sobborghi nella quale gli operai andavano a coltivare le loro velleità da boxeur, fu tramortito da un diretto e due ganci che gli fecero saltare i due denti che gli erano rimasti in bocca. Pel di carota fini con la faccia nella pozza di sterco, frutto del lavoro di Ferruccio e i suoi amici dovettero trascinarlo a fatica sotto una pompa di acqua gelata per farlo rinvenire. Donato e Rosario Mastrobuono avevano assistito alla scena dalla finestra del loro ufficio. Si guardarono e sorrisero.

…Nella piccola stalla del casolare di Donna Felicetta, Nicola vegliava in attesa di quella che sarebbe stata la mattina della sua esecuzione. Non aveva potuto difendersi perché non c’era stato alcun processo. I soldati avevano creduto alle parole di Mastro Cenzino e tutto in poche ore sarebbe finito. Le mani legate dietro la schiena erano intorpidite dalla stretta della corda e un rivolo di sudore gli scorreva dalle tempie fino a inzuppargli la barba incolta. Una rabbia impotente gli gravava sulle spalle come un peso che qualcuno gli avesse inopinatamente imposto. Con il passare dei minuti lo prese la stanchezza. Guardò l’incerta luce della luna tra le nuvole che la tagliavano veloci, ma non riusciva a pronunciare nessuna preghiera contro quello che sembrava un destino ormai scritto. Si addormentò in ginocchio, chinando il mento sul petto. Nel sonno disturbato, riuscì a percepire un lieve rumore che proveniva dalla porticina della stalla: qualcuno stava cercando di entrare. Stette in silenzio. L’ombra gli si avvicinò alle spalle e senza proferire parola si adoperò lentamente per slegare il nodo della fune che gli bloccava le mani. “Chi sei?” Mormorò tra i denti U’ubestiu ma non ebbe risposta. Dalla delicatezza dei gesti, comprese che non si trattava di mani maschili. Tuttavia quel tocco aveva qualcosa di strano, una sequenza di movenze impalpabili nelle quali nulla era lasciato al tentativo, ma tutto era sicuro e risolutivo. Nicola sentì che le mani erano libere, si sfregò i polsi indolenziti. Si girò per veder chi fosse quel liberatore e grande fu la sua sorpresa quando si accorse che la figura alle sue spalle era scomparsa, lasciando la porta aperta. Al turbamento causato dalla situazione in cui si trovava fino a qualche attimo prima di essere slegato, si aggiunse una strana sensazione per quella libertà inaspettata e sperata. Uscì ne l’aia. U’ubestiu non ebbe il tempo di ragionare: un fruscio proveniente da l’abitazione lo mise in allarme. Si allontanò velocemente…

…I cani avevano abbaiato tutta la notte tanto che Mastro Cenzino si era messo in allarme perché credeva sarebbero arrivati un terremoto o una disgrazia. Si affacciò alla finestra ma tutto sembrava tranquilla nel panorama delle colline ordinate, oltre le quali si estendeva la sua proprietà. Anche qui la luna concedeva di scorgere i fianchi dei campi arati di fresco, le macchie oscure di querceti e il mulino incastrato nella fiumara. Rimase paralizzato dal terrore quando sentì il freddo di una lama appoggiata sul collo e una mano che gli tappava la bocca: “La senti, bastardo? – una voce roca, carica di risentimento gli fischiava ne l’orecchio – avrei potuto scannarti come un porco, uno di quelli che rubi ai poveri contadini con la scusa che sono stati iscritti al partito, così ti compri il loro silenzio. Io invece voglio aspettare – continuò U’ubestiu – desidero che tu viva con il terrore che un giorno di questi io possa tornare la notte ad impiccarti alla trave maestra del tetto – Mastro Cenzino sentiva mancargli le gambe, lo specchio appoggiato alla parete, rifletteva la paura nel suo volto. Riconobbe Nicola – ascolta le parole di Nicola U’ubestiu: compirò il tuo destino quando meno te lo aspetti, non importa se tra un mese, un anno o venti. Hai finito di dormire la notte” Nicola guardò la sua immagine riflessa nello specchio mentre la lama premeva sul collo di Cenzino. Gli occhi del fattore erano iniettati di orrore. Nuovamente U’ubestiu si bloccò davanti alle sue pupille come quelle che tanti anni fa Nicola aveva visto implorargli pietà. Lasciò la presa e fuggì mentre Mastro Cenzino si accasciava piangendo nella pozza della sua urina.
Fine sesta parte
L’odio dopo la paura. L’unico motivo per il quale si rimarrà vivi quando la compassione sarà merce scaduta, perché ognuno di noi ha avuto brama di essere compreso, ogni volta che ha aperto la finestra e ha capito dove la vita avrebbe girato la curva del mutamento definitivo. Alla voce squillante del Dantes di fresco recluso, sì è sostituito un muto lamento, flebile come una camera d’aria bucata che rilasci lentamente il suo contenuto. Le schermate nelle quali, a notte, si cerca tra le righe la normalità perduta, l’illusione che sia stata solo una “interruzione di coscienza”, diventano il luogo nel quale il risarcimento per una colpa non commessa, trovi il giusto ristoro. Dagli altri si pretende comprensione mentre gli altri sono alla disperata ricerca dei ricordi non ricordati, della vita non vissuta, dei lavori non lavorati, della morte, questa sì che non si è potuta piangere. Una linea alla quale mancherà un tratto, due semirette distanziate da uno spazio vuoto nel quale avremo creduto di poter vivere un tempo buono per noi.
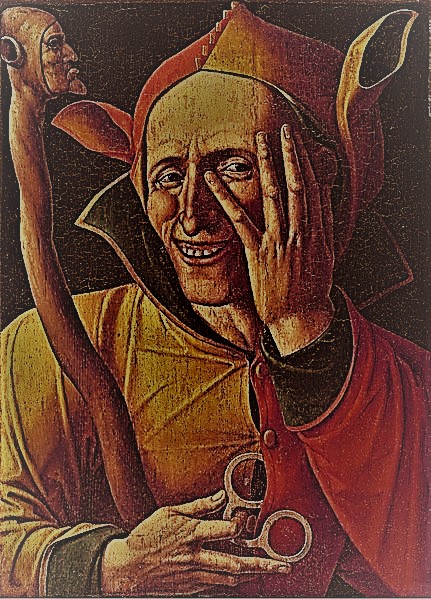
Quando si tornerà a respirare piano, il colpevole apparirà e avrà le forme che più desideriamo: potrebbe essere un uomo di potere o un conoscente, una legge indecifrabile, una transenna che non ci farà bagnare i piedi nel mare d’estate, una scia, un extraterrestre, un vicino con la tosse, un dio beffardo che ha disconosciuto le sue creature. Riusciremo a scordare la libertà che non abbiamo mai avuto, provando la colpa quando alzeremo un bicchiere per vedere il colore del vino alla luce del sole, quando l’aria di montagna non riuscirà ad entrare nei nostri polmoni, stretti per non rubare il fiato a chi soffre. Nessuno racconterà di un tempo fermo perché non sarà la storia a cambiare noi ma l’inanità del combattere contro un avversario il quale non riflette la sua immagine nello specchio. Le formiche vinceranno sul nostro ex-essere cicale, quando il superfluo sarà un crimine e i fiori saranno solo fiori. Dietro le maschere troveremo conforto nello sforzo di celare le smorfie che hanno mutato il nostro viso.
Si potrà vivere qualsiasi emozione senza la paura che qualcuno scorga nei nostri sguardi il mio accenno di debolezza. Gli occhi diverranno l’unico legame tra noi e gli altri, occhi nei quali un giorno non ci fu dato il coraggio di guardare e dentro la loro vetrata umida ora saremo costretti a leggere quello che la parola non può rivelare. Saremo profondi e stupidi, meno diversi di prima più simili a quello che non avremmo voluto essere, cattivi dietro la maschera quella che abbiamo indossato ogni giorno della nostra vita mai vista, proprio la stessa che ci copre il viso liberandoci dal peso di portarla.

Ferruccio si presentò l’indomani mattina presso il piccolo mattatoio dei fratelli Mastrobuono. Lo accolse l’ometto che aveva conosciuto il giorno prima. “ Ieri non mi sono presentato, sono Giuseppe e sono il tuttofare dei fratelli Rosario e Donato”. Mi sembri un giovane che ha voglia di lavorare, penso che i padroni non avranno difficoltà a trovarti un posto nella ditta”. Da lontano, nel capannone arrivavano i lamenti del bestiame che era raggruppato a l’interno, in attesa di essere abbattuto per la macellazione. Ferruccio dovette raccogliere tutte le sue forze quando udì il lamento delle pecore che erano portate a l’olocausto. Comprese come le possibilità di rimanere in quel posto a lavorare dipendessero dalla sua capacità di evitare che le immagini della miseria che aveva lasciato potessero ritornare nella sua mente a tormentarlo. Nel minuscolo ufficio i fratelli Mastrobuono avevano sistemato le scrivanie una di fronte a l’altra quasi volessero controllarsi a vicenda in una sorta di contesa costante per la gestione della ditta. Le attitudini di verse avevano deciso per loro, quali fossero i compiti ai quali erano destinati: Rosario, meno avvezzo ai conti, era più propenso a passare il suo tempo tra le bestie, girando il paese il lungo e in largo, alla ricerca dei capi migliori. La sua conduzione delle trattative, quando si recava presso i ranch o gli allevamenti, era qualcosa che somigliava maggiormente a una sceneggiata napoletana alla quale sottoponeva i cow boys. Con la sua gestualità riusciva a convincere anche il più burbero dei cow boys sul prezzo di una bestia. Abituato alle pozze di fango nelle quali sguazzavano le sue bufale a Battipaglia, sin da piccolo, comprendeva la rudezza del lavoro svolto da un bovaro texano e riusciva a stabilire un contatto fatto più di sofferenze comuni che di parole. A differenza di Rosario, Donato era l’uomo di affari, quello che aveva costruito tutta la rete di clienti a Boston e dintorni, dalle macellerie ai ristoranti, alle mense. A lui si doveva l’espansione rapida della ditta e molti vociferavano che non si trattasse solo di meriti suoi, ma che molto avesse contribuito l’amicizia con un piccolo gangster della zona. In ogni caso i fratelli Mastrobuono capivano quale fosse il limite oltre il quale non era prudente spingersi. Nella loro ditta cercavano, per questioni di convenienza, di assumere solo italiani, irlandesi e qualche nero, perché ritenevano si trattasse di gente più bisognosa e capace di sopportare anche i lavori più duri, senza fiatare. Lo facevano anche per un altro motivo: ai Mastrobuono piaceva la boxe e ogni tanto, fra i loro dipendenti, capitava che ci fosse un ragazzo bravo a menare le mani, tanto che qualcuno di questi si era trasformato in un valente pugile, al soldo del suddetto gangster.

Nella piccola masseria una volta occupata da Donna Felicetta, la mano invisibile di Nicola, era riuscita a conservare il ricordo di quella creatura che aveva acceso una promessa d’amore verso quell’uomo del quale aveva solo incrociato lo sguardo. U’ubestiu abitava nella povera casa e i pochi abitanti di Cutruni avevano imparato ad amarlo per ciò che aveva fatto, tentando di salvare i paesani da l’eccidio. Nonostante la considerazione per quell’uomo solitario ma coraggioso, nel paese c’era anche chi non vedeva di buon occhio che Nicola abitasse quella casa rimasta ora senza un proprietario. In particolare Mastro Cenzino Di Gravio, commerciante di carbone e gasolio il quale, dopo aver fatto affari in tutta la vallata con i fascisti e i tedeschi, dopo la liberazione aveva preso contatti con le forze alleate di cui era diventato uno dei principali fornitori nella zona. Il suo motto “pecunia non olet” era stampato a lettera cubitali contro il paraurti del vecchio Isotta Fraschini con il quale praticava i suoi commerci nella zona. Prima che la guerra scoppiasse, aveva avuto una predilezione particolare per Donna Felicetta, arrivando anche a farle proposte di matrimonio, alle quali la donna aveva sempre opposto un risoluto diniego. Mastro Cenzino non era uomo da farsi sbattere la porta in faccia e, per tutta risposta, aveva impedito a Donna Felicetta di acquistare la sua merce tanto che la sventurata, per ripararsi dai rigori dell’inverno, era stata costretta a procurarsi legna nei boschi onde potersi scaldare e cucinare. La storia de U’ubestiu e di quell’amore breve e impossibile tra lui e la donna, era arrivata all’orecchio di Mastro Cenzino e l’astio per non aver potuto vendicarsi su Felicetta, fece sì che il commerciante riversasse i suoi propositi di vendetta su l’uomo il quale con un solo sguardo aveva conquistato la sventurata. Forte dei suoi appoggi con gli alleati, si accreditò come l’unico in grado di ristabilire l’ordine a Cutruni, in attesa di libere elezioni e divenne reggente della comunità. Rivolse attenzione immediata alla piccola masseria, dove ora U’ubestiu tentava di preservare il ricordo di Felicetta. Quando le jeep con gli ufficiali e i soldati alleati arrivarono sullo spiazzo antistante a l’edificio in pietra, Nicola era intento a zappare il piccolo orto che aveva predisposto davanti la casa. “Che volete?” Chiese perentoriamente U’ubestiu, i militari non degnarono della minima attenzione Nicola e sfondarono la porta dell’abitazione, mentre altri soldati iniziavano a portare dentro pesanti casse contenenti armi e vettovaglie. Nicola, non ebbe il tempo di considerare le conseguenze dei suoi gesti e si scagliò con forza contro quelli che avevano osato profanare quel luogo a lui così caro. Per tutta risposta i soldati colpirono U’ubestiu con il calcio dei loro fucili fino a farlo stramazzare al suolo. “Maledetti, questa casa è sacra!” Urlava Nicola mentre i soldati continuavano a colpirlo.

“ Comandante, vedo che avete fatto conoscenza con questo criminale” Mastro Cenzino era arrivato a cavallo dal paese “Lo cercavo da qualche tempo, è una spia al servizio dei fascisti”. Nicola non credeva alle sue orecchie, come poteva quell’uomo accusarlo di una cosa così meschina quando tutti sapevano quello che lui aveva fatto per gli abitanti di Cutruni? Subito comprese che gli unici a non sapere di quella storia fossero proprio gli alleati i quali si fidavano di Mastro Cenzino. “Non è vero, tu menti, bastardo!” Urlava U’ubestiu cercando disperatamente di farsi capire dai soldati ma questi non sembravano minimamente dare ascolto alle sue parole. Mastro Cenzino con un sorriso simile a una smorfia terribile si avvicinò a comandante del plotone e stette a parlare con lui per qualche minuto. Subito dopo fu ordinato ai soldati che legassero Nicola e lo chiudessero nel porcile. “Cosa gli hai detto, maledetto?” Urlava U’ubestiu nei confronti di Mastro Cenzino. “Addio Nicola- rispose l’uomo prorompendo in una risata – recita le tue ultime preghiere, per te domani è finita”. Detto questo, Mastro Cenzino si voltò e ripartì a cavallo in direzione di Cutruni tra le grida e le maledizioni de U’ubestiu.
Nicola non pianse una lacrima. Nella sua vita passata a consumare la rabbia verso un Dio che si era preso gioco di lui, aveva ritenuto che la migliore vendetta verso gli altri fosse quella di non dimostrare la propria debolezza, neanche davanti alla morte. Ora stringeva tra le braccia quel corpo morto. Non c’era stato nulla fra loro ma Nicola aveva capito, in quei pochi istanti nei quali aveva tenuto stretta al petto quella donna, che c’era qualcosa di diverso dalla sua solitudine. A questa c’era abituato tanto che la viveva nella sua normalità ma proprio questi brevi momenti passati con Donna Felicetta lo avevano portato alla consapevolezza che era invecchiato da solo. All’improvviso qualcosa riemerse dal profondo della sua memoria come se, questo sconosciuto dolore che ora provava per quella donna, avesse riportato a galla un periodo della sua vita seppellito nel dolore: Ferruccio. Fu sufficiente quel nome a fargli comprendere quei trent’anni passati nel bosco a nascondersi da un nemico invisibile: la rabbia per la sorte avversa, quella che aveva costretto i due amici a prendere strade così lontane. Che cosa stava facendo ora Ferruccio, era morto in guerra o era lontano? Un altro sentimento stava prendendo piede nel suo animo e Nicola se ne accorse, tanto che scacciò subito dalla sua mente l’immagine dell’amico: la nostalgia. Ora sentiva il peso dei suoi anni e di quello che gli sarebbe mancato di lì in poi. Seppellì la donna vicino la sua abitazione, ai margini della faggeta. Recitò quelle preghiere che ancora ricordava. Guardò ancora la sepoltura poi si voltò e sparì nuovamente nel bosco.
…Nei mesi a seguire i superstiti dell’eccidio di Cutruni, evitarono di frequentare la faggeta dove U’Bbestiu si era rifugiato. Le leggende sul suo conto si alimentavano. Altri soldati tedeschi erano scomparsi misteriosamente ma questa volta le SS ritenevano che non valesse la pena fare rappresaglie in un paese già oggetto di una strage, tanto che era costantemente visitato da squadre di partigiani pronte a vendicare la carneficina. I paesani più coraggiosi che andavano a far legna nella faggeta narravano di come la sepoltura di Donna Felicetta fosse sempre ordinata e pulita, e di come una mano invisibile ponesse sempre dei fiori alla base della croce. Quando il fronte passò, Cutruni divenne la base operativa del comando alleato. I pochi superstiti, travolti da l’euforia della liberazione, dopo tanti episodi tragici, si dimenticarono pure de U’ubestiu. Il comandante delle truppe, insieme con una troupe di giornalisti e reporter di guerra trovò ottima sistemazione nella masseria una volta abitata da Donna Felicetta. Fu una sera particolarmente calda di primavera quando Paddy, giovane giornalista di origini irlandesi, proveniente da una famiglia impiantata a Boston, era intento a fumare una sigaretta non lontano da l’abitazione, che U’ubestiu fece sentire la sua presenza. La luna riusciva sufficientemente a illuminare la radura alle pendici della faggeta. In quella zona, la piccola sepoltura di Donna Felicetta era passata quasi inosservata agli occupanti dell’abitazione. A un tratto, un’ombra sgusciò fuori dagli alberi e si diresse verso la radura. Paddy gettò in terra la sigaretta e imbracciò il fucile. L’individuo misterioso non sembrò essersi accorto della presenza di un militare a l’esterno. Fu grande la sorpresa di Nicola quando, intento a sistemare i fiori sulla tomba di Donna Felicetta, sentì sul collo la canna fredda del fucile. “Ehi you!”. Nicola alzò le mani e si girò. L’aspetto selvaggio dell’uomo colse di sorpresa il giovane irlandese, tanto bastò a Nicola per strappargli il fucile dalle mani e correre a nascondersi nel bosco.

L’avvenimento suscitò molta curiosità nella truppa e fu occasione di scherno da parte dei commilitoni verso Paddy. Il ragazzo non si levava dalla mente quell’incontro e iniziò a chiedersi come mai, quella sepoltura, pareva essere mantenuta in perfetto ordine, come se qualcuno se ne prendesse quotidianamente cura. Paddy provò anche a tenere qualche posta sperando di cogliere di nuovo sul fatto U’ubestiu ma, per quanta attenzione ponesse, Nicola era diventato più astuto di lui. Fu così che Paddy, da giornalista quale lui era, iniziò a fare domanda in paese. All’inizio, molti cutrunesi erano restii a parlare de U’ubestiu ma poi il vecchio Saro, uno dei pochi superstiti della strage compiuta dai tedeschi narrò la vicenda di Nicola e di Donna Felicetta. Nelle sue cronache di guerra Paddy, oltre agli articoli ufficiali, riportò anche numerose storie che si erano intrecciate con i combattenti e gli uomini dei paesi liberati. La storia di U’ubestiu gli rimase più di tutte nel cuore anche quando, una volta a Boston, tornò a lavorare per il quotidiano della sua città.
Fine quarta parte
Donna Felicetta fu prelevata insieme con gli altri. A nulla valsero le implorazioni delle madri perché risparmiassero i figli. Le urla e i gemiti riempivano l’aria del paese. I piccoli piangevano stretti ai fianchi delle donne, il palazzo comunale conteneva il dolore di tutta quella piccola umanità che non aveva alcuna colpa se non quella di essere innocente. Solo un uomo sentiva tutto il peso di quello che aveva fatto: U’Bbestiu. Se non avesse ucciso quei tedeschi, forse avrebbe risparmiato a quella comunità un delitto così grave. O forse no? Forse quei contadini anziani, che ora rimanevano fermi al centro della piazza, sarebbero stati uccisi lo stesso per un capriccio di qualche SS. Un giovane soldato tedesco, in attesa di ricevere l’ordine di sparare sugli ostaggi, osservava il ragazzo allampanato che gli si parava davanti, le mani legate dietro la schiena, in attesa di morire. I suoi occhi neri erano la domanda, quella che quel fuciliere si sarebbe posto per tutta la vita, ammesso che fosse riuscito a sopravvivere alla guerra. Si udirono alte le grida dei prigionieri nell’edificio quando nella piazza echeggiarono le sventagliate dei mitra. Sul selciato rimasero pastori, contadini, e qualche bottegaio troppo vecchio per andare in battaglia. Subito dopo il comandante ordinò di appiccare il fuoco all’edificio nel quale i sopravvissuti erano stati rinchiusi. Le fiamme si alzarono senza che i prigionieri avessero possibilità di fuga. Qualcuno, nel delirio generale, sfondò un vetro e tentò di saltare fuori ma, una volta caduto in strada veniva subito falciato dai mitra dei soldati. Altri seguirono la stessa sorte. L’edificio era simile a quei vespai dai quali, una volta andati a fuoco, gli insetti uscivano morenti terminando il loro essere con la loro libertà. Solo Donna Felicetta non faceva nulla. Rimaneva seduta ad aspettare che le fiamme la lambissero e la avvolgessero. Mentre le fiamme consumavano la casa comunale dalle fondamenta, i tedeschi decisero di abbandonare il posto come si fossero resi conto dell’orrore compiuto. Il fumo aveva invaso tutte le stanze e molti ragazzini giacevano ormai senza vita tra le braccia delle madri, le quali gemevano per le ustioni nel tentativo di salvare gli altri tra le fiamme. Le urla e la concitazione nel tentativo di salvarsi avevano presto lasciato il posto alla rassegnazione soffocata dai colpi di tosse e dai rantoli.

Donna Felicetta si era rannicchiata a terra ora, sperava che, facendosi piccola, la morte non si sarebbe accorta di lei. All’improvviso il portone principale venne giù in un colpo solo. La luce dell’esterno, filtrata dalla coltre di fumo, disvelò la figura di un uomo possente, completamente rivestito di una pelliccia di montone zuppa di acqua. L’uomo iniziò a prendere tutti i bimbi che avevano ancora un po’ di vita in corpo e a portarli in salvo sul selciato della piazza. Entrava nell’edificio sfidando le fiamme e subito ne usciva tenendo in braccio una donna, un ragazzo o un vecchio. L’edificio stava per essere completamente avvolto dalle fiamme e U’Bbestiu ormai esausto, tentò un’ultima sortita. Si accorse solo per caso della presenza di Donna Felicetta, la quale giaceva a terra senza dare più alcun segno di vita. La trasse in salvo prima che il solaio del primo piano crollasse. Era stremato, bruciacchiato, tossiva ma tentò in tutte le maniere di far rimanere in vita la donna. La portò nella sua masseria e la depose nel suo giaciglio. La donna era ustionata gravemente. A tratti riprendeva conoscenza, molto spesso cadeva in un profondo deliquio. Nicola la accudì tutta la notte. Lei lo guardava come quella sera, quando lo aveva sorpreso a prendere i viveri che gli aveva lasciato davanti alla porta. Non si dissero nulla, come allora, forse perché non c’era più nulla da dirsi. All’alba le condizioni di Donna Felicetta peggiorarono nonostante Nicola si adoperasse per curarla. Negli occhi della donna comparve la paura della morte. Fino a quel momento aveva guardato quell’uomo con tenerezza e riconoscenza, ora il suo sguardo era quello che Nicola conosceva bene, lo stesso che aveva visto negli occhi del suo ultimo agnello prima che lo sgozzasse. La Donna gli spirò tra le braccia.

Per un italiano arrivato in America, senza soldi e senza istruzione, i lavori possibili erano solo quelli dove ti dovevi fare i calli alle mani, bestemmiare la sorte e mangiare una zuppa fredda nelle ciotole di latta ammaccate nella pausa pranzo, sperando che qualcuno ti passasse un mezzo mozzicone per farci un tiro. Ferruccio fu subito attirato da voci italiane che stavano baccagliando tra gli ormeggi del porto. Un grosso autocarro era accostato a una piccola nave mercantile e dalla stiva, alcuni operai stavano scaricando dei quarti di bue per poi trasferirli sul cassone del mezzo. “Ce l’hai la forza cumbà?” gli disse un omino dai capelli appiccicati sulla fronte, il quale stringeva una cartella degli appunti, sulla quale stava segnando il numero dei capi. Ogni tanto si levava dalla bocca un mezzo sigaro puzzolente per imprecare in un dialetto che a Ferruccio rimaneva incomprensibile. Ferruccio pensò bene che guadagnare qualche dollaro gli avrebbe fatto bene per procurarsi una cena decente. “ Mi raccomando, non piegare le gambe, sennò sei morto”. Ferruccio aveva già fatto quel lavoro qualche volta, quando a Cutruni il bovaro del villaggio ammazzava le vacche migliori per venderle in città. Sapeva che un quarto di bue poteva pesare più di cento chili e se non lo avesse preso correttamente, si sarebbe potuto spezzare pure la schiena.
Dopo un attimo di esitazione, quando lo scaricatore gli aveva messo il primo quarto sul collo, Ferruccio iniziò a lavorare senza battere ciglio. Alla fine della giornata era stremato ma riuscì a cavare il necessario per pagarsi un letto per la notte ed un pasto caldo. Gli fece strano avere sottomano i suoi primi dollari. Li girava e rigirava mentre l’ometto della carne se lo guardava con l’aria di chi aveva trovato un nuovo vigoroso paio di braccia. “Come ti chiami, ragazzo?” chiese l’ometto. “ Ferruccio e sono sbarcato oggi”. “ Ferruccio – replicò l’uomo – sai lavorare, fatti vedere domani dal boss” e indicò l’insegna sul lato del cassone del camion : “Mastrobuono Brothers – Best meat”.
Donna Felicetta, portava il nero della vedovanza anche quando dormiva. Aveva ormai passato la quarantina ma era ancora una donna sulla quale il tempo pareva non aver fatto presa. La grande guerra gli aveva portato via il marito, prima che avesse tempo di figliare. Da allora si era ritirata ai margini del paese, a curare da sola la campagna e le bestie. A tutti gli uomini liberi aveva detto no, preferendo conservare il castigo del lutto quasi che una sorta di maledizione l’avesse colpita come la granata che aveva ucciso il suo compagno. Sapeva di essere ancora una bella donna ma a nessuno concedeva un sorriso. A Cutruni era l’unica cui U’Bbestiu non faceva paura, forse perché Nicola non si era mai interessato a lei. Donna Felicetta aveva iniziato a provare una certa curiosità e spesso aveva lasciato sulla porta di casa del cibo affinché anche U’Bbestiu si accorgesse di lei. Nulla era accaduto per mesi fino a quando, una notte d’inverno nella quale la neve copriva per metà le porte delle case di Cutruni, aveva udito lo scricchiolio di alcuni passi vicino la finestra. Anche quella sera aveva lasciato qualcosa da mangiare per Nicola sull’uscio. Corse subito alla porta con il desiderio di sorprendere U’Bbestiu ma quando se lo trovò davanti, Nicola non accennò a scappare. La guardò con gli occhi che sembravano tizzoni ardenti a malapena visibili, tanto erano nascosti dalla barba e dal cappellaccio che l’uomo si era cavato in testa. Donna Felicetta sentì qualcosa salirle fino alla gola. Era una sensazione che non ricordava eppure tanto tempo prima l’aveva provata. U’Bbestiu fece un piccolo cenno del capo, come a voler ringraziare, quindi sparì nella tormenta.

A Ferruccio la nave piaceva. Per lui che era un uomo di montagna, abituato alle salite e alle discese, lo spettacolo orizzontale del mare emanava un certo fascino. La sensazione che quella distesa senza limiti lo avrebbe portato in una condizione nuova, dove tutto sarebbe stato possibile. Aveva rimosso completamente la possibilità di tornare alla sua terra. Comprese come quelle montagne che una volta aveva vissuto con la rassegnazione di chi, per nascita era destinato a non andare oltre, erano state per lui un ostacolo che gli aveva impedito di guardare il mondo. “ Non ci torno più” andava ripetendo anche quando i suoi compagni marinai, gente che era nata sulla costa, gli chiedevano della sua terra e del suo gregge. Ferruccio all’improvviso si adombrava: non era il rimorso per aver lasciato che le sue pecore morissero ma il sacrificio dell’ultimo suo agnello. Rivedeva la sua mano puntare la lama alla gola della bestia, poco prima di colpire. Nel silenzio dentro il quale lasciava i suoi interlocutori, i suoi occhi si bloccavano in un punto imprecisato dell’orizzonte, era allora che lo sguardo di quell’agnello gli restituiva tutto il senso dell’orrore di cui era stato vittima e responsabile. Il sacrificio inevitabile di quella bestia lo aveva spinto a cercare un altro destino e una sorte differente…
A Boston gli fecero scontare la quarantena. Stette ammucchiato dentro un capannone per giorni, insieme a alcune famiglie d’italiani che avevano preferito arrivare in quella città piuttosto che sbarcar a “Nuova York” come la chiamavano loro. “Lì, i controlli sono più severi e ti rimandano a casa, anche se ci ha solo un colpo di tosse” gli raccontò Bastiano, un contadino che si era portato dietro tutta la famiglia. Le due figlie e la moglie di Bastiano ascoltavano l’uomo mentre parlava con Ferruccio. “Le vedete quelle valigie sulle quali stanno sedute le mie figlie? Quelle me le ha date mia sorella maggiore: Anna. Lei è dovuta tornare indietro. Ha aspettato quaranta giorni, chiusa dentro l’ospedale di Ellis Island insieme con gli altri. Dicevano fosse la terra della libertà. Guardava dalle sbarre quella statua, illuminata anche di notte: comm’è belle, Bastià! Non la smetteva più di tossire, ma cercava di nascondere il rantolo, dentro lo scialle. Aveva comprato quelle valigie al mercato di Patierno. Vedete la pelle com’è bella ancora, sono due valigie uguali, di vacchetta. Le teneva sotto il letto, prima di metterci i quattro stracci da portare in America. Ci aveva messo pure una statuina della madonna che schiaccia il serpente col piede e una foto della famiglia. La tosse non se ne andava. La notte, mia sorella tremava al pensiero che i custodi se ne accorgessero e la portassero dalla guardia medica. Ma non poteva più nascondere. Già lo sapeva che per lei la vita non avrebbe potuto cambiare. Il ventesimo giorno la mandarono a fare la visita dal dottore. Gesù, teneva na’ faccia! Senza espressione, come il marmo delle tombe vecchie. Al suo fianco, ci stava nu’ giovane italiano, con i baffi tirati in su, che traduceva tutt’ chell ca dicev’ o miedico, con accento napoletano. “Signorina, ha detto che a Nuova Yorka non ci potete entrare, siete malata, sembrate “na’cosa secca”. Chi se la prende la responsabilità, se portate in giro per la città la malaria o la tubercolosi? Guardate, non è possibile. Ma come vi è venuto in mente di partire!” Così l’hanno rimessa sopra al ferry boat e ha dormito sopra le valigie. Ha sempre pensato: se Bastiano che ora è solo un ragazzo, un giorno vorrà partire, serviranno a lui per tentare un’altra traversata, per tenerci dentro le sue povere, per andarsene via da questo posto. Così me le dette, quando decisi che sarei venuto a Boston.” Con le lacrime agli occhi. Ferruccio si rese conto di quanto era stato fortunato ad arrivare. Ora toccava a lui farsi strada in quella terra sconosciuta. La quarantena passò senza tanti problemi. C’era da trovare un lavoro.
La morte dei tre soldati non passò inosservata. Qualche giorno dopo, non ricevendo notizie, un’altra pattuglia compì la perlustrazione della stessa zona, riuscendo a recuperare i cadaveri. Al Comando, si fece strada l’idea che qualche abitante del luogo avesse già organizzato azioni di resistenza. Quest’atto, in ogni caso, non poteva passare impunito. I tedeschi decisero di compier una rappresaglia. Erano decisi a stanare questi partigiani, a tutti i costi. Pensarono di rastrellare uomini, donne e bambini per dare una lezione “terribile e degna di essere ricordata per lungo tempo” salvo che qualcuno rivelasse i nomi dei sabotatori. Nella piccola piazza di Cutruni, i pochi uomini che abitavano ancora il paese furono radunati sotto la minaccia delle armi mentre donne e bambini furono rinchiusi dentro il piccolo edificio comunale.
Fine seconda parte