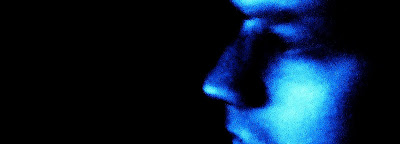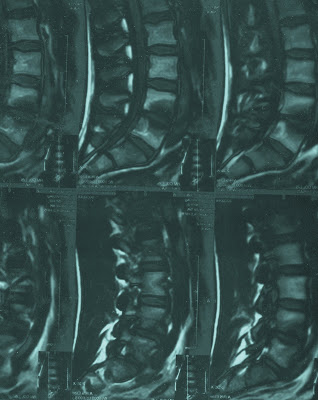Dapprima riuscendo a fare qualche passo, ora, superati i due anni, stava a mala pena di traverso, poggiando, il suo muso sulla tavoletta del water. Tuttavia il maiale non se ne doleva, dimostrando un certo interesse al movimento solo quando Antonino, a sera, gli portava un secchio di bucce varie. La fortuna del maiale gli era capitata un mattino che il treno merci e rifornimenti tedeschi era passato per la stazione diretto verso l’Umbria. “Antunì! Antunì!” Aveva gridato la sorella zi’ Pierina, dai binari per richiamare l’attenzione di Antonino che teneva la figlia maggiore con la testa vicino alla locomotiva, per fargli aspirare il vapore a mo’ di aerosol.. Erano tanti poveri a fare quale tipo di cura termale a costo zero. Un’asse del vagone si era rotta e da questa spuntava il muso vispo di un maiale, che tentava invano la fuga. Vedere il maiale, e ficcarlo sotto le gonne della sorella, per Antonino fu tutt’uno. In verità la sorella era talmente secca che ai militari di scorta venne qualche dubbio nel vedere quell’arcolaio ambulante con quel pancione. Data la necessità il maiale fu ospitato nel bagnetto fra l’ilarità delle figlie. Ma Antonino aveva una mania che era quella della pulizia. Non sopportava la sola idea della puzza di maiale, quindi aveva preso l’abitudine di strofinare l’animale ogni sera, prima di andare a dormire, così come si usa per i purosangue. Passava la sua bella mezz’ora nel cesso e dava di brusca e striglia. L’unico problema era la presenza dell’ingombrante suino, ogni volta che qualche membro della famiglia, doveva fare i sui bisogni. Chi si sedeva sulla tazza , era costretto a tenere il muso del maiale, sulle ginocchia. Il norcino, aveva temperamento mite e riflessivo e ben si adattava alle esigenze degli inquilini. Mentre mamme, figlie , mariti erano intenti a sforzi liberatori, il maiale li guardava con pazienza. A volte le attese , data la scarsità del cibo, davano luogo a lunghe sedute ed esigui risultati. Gli umani, invece delle più moderne letture, avevano iniziato a parlare con il suino. Le figlie, gli ripetevano le poesie, assegnate da mandare a memoria, a scuola e i genitori si lamentavano per i problemi dovuti alla guerra ed al regime. Con il passare del tempo, il maiale, veniva addobbato con sciarpe e berretti. La famiglia di Antonio, proveniente da una stirpe di ferrovieri spoletini, era di orientamento socialista, e di quei tempi era cosa da tener nascosta. Antonino aveva la tessera annonaria e quella del partito aveva dovuto sotterrarla, per poter campare. Provava un rancore feroce per i fascisti che poteva sfogare solo in aperta campagna, quando andava ad installare i pali del telegrafo. Pensò quindi di vendicarsi e ,dato che parlava con il maiale, aveva deciso di chiamarlo Benito. Ma la storia del maiale non era passata sotto silenzio, specialmente al vicino di casa “Luchittu” che era un picchiatore per il gerarca Morante. Luchittu, riteneva che il possesso di quel maiale, dovesse essere denunciato al partito, perche’ la cosa gli risultava sospetta. Fece presente la cosa al suo superiore affinchè fosse effettuato un esproprio “fascista” . Il clima in città era già abbastanza caldo, sebbene L’Aquila fosse una città completamente entusiasta del regime. Ma il fratello di Antonino, Loreto, che era un militante socialista, già purgato più volte, aveva anche lui i suoi informatori. Avrebbero potuto rimetterci la pelle. Loreto ed i suoi compagni erano d’accordo per quella sera. Ne avevano parlato nella cantina, adibita a sezione del partito, per giorni. Si sarebbero visti a piazza Duomo per le otto, dove la ronda di fascisti capeggiata da Morante, sarebbe dovuta partire, come ad avvertire i piccoli gruppi di aquilani che sostavano a parlare, più del dovuto, fino a tardi. Alcune sezioni ne circoli di comunisti e socialisti, erano state già chiuse in città e le adunate di amici erano guardate con sospetto dalle camicie nere. Loreto aveva tanti amici che erano passati dalla parte di Mussolini. Era già stato segnalato come elemento sovversivo La serata era fresca, di quelle serate aquilane, di fine aprile, dove riesci a sentire l’aria ancora pungente. mista alle fioriture dei giardini ed alle goccioline delle fontane. I magazzini Del Vecchio stavano chiudendo. Il gestore, aveva abbassato la serranda, in fretta e stava attraversando la piazza in diagonale. Loreto ed altri quattro, spuntarono da dietro la chiesa. Loreto si sporse per veder meglio. Fu allora che sentì il rombo della Balilla arrivare dai portici. La macchina precedeva lentamente, era carica di fascisti. Loreto preparò l’esca. Lui ed i compagni attraversarono la piazza, correndo, nel momento stesso nel quale la macchina sbucava dal corso. I fascisti videro quello strano movimento, accelerando immediatamente. La macchina saltò sul pavimento rialzato dello slargo cercando di tagliare la strada ai fuggitivi. Correndo a perdifiato Loreto si nascose insieme agli altri, lungo la via che dava verso piazza del Palazzo Rivera. Riuscivano a sentire, le voci concitate dei fascisti. Poi, la macchina imbucò lentamente, il vicolo dove si erano nascosti. Le camicie nere procedevano lentamente nel buio della strada, tenendo le braccia fuori dai finestrini, con i manganelli in mano. Arrivarono sul punto. Dall’oscurità, i cinque, sbucarono. Furono pochi istanti. Loreto e di suoi, afferrarono la parte bassa della carrozzeria dell’auto ed incominciarono ritmicamente a sollevare la macchina, prima da un lato, poi dall’altro. I fascisti urlavano e minacciavano, agitando i manganelli, tentando di colpire gli attentatori.
Qualcuno tentò di aprire lo sportello. Era troppo tardi. La macchina si ribaltò con un rumore di lattina accartocciata. Loreto e gli altri iniziarono a correre senza guardarsi indietro. L’attentato riuscito sviò l’attenzione dal maiale di Antonino, anzi Luchittu fu accusato di aver spinto i fascisti nell’agguato e fu spedito, dopo una settimana di olio di ricino, a badare alle vacche a Roio Piano. La fame intanto incalzava ed il maiale, sempre più grosso, era diventato un’attrazione troppo forte per la famiglia Panetto. Eravamo ormai nel settembre del ’43 e la notizia della Liberazione, non fu accolta benevolmente dagli aquilani, specialmente quando i tedeschi, il 12, entrarono in città, durante la ritirata. Molti episodi di violenza si verificarono, nei confronti dei cittadini nelle frazioni ed Antonino, temette più per la sorte del suo maiale, che per quella dei suoi figli. Passò la primavera senza incidenti ed Antonino vide la fuga dei tedeschi il 14 giugno. Era felice raggiante. Nel trambusto dell’arrivo de Comitato di Liberazione Nazionale, tutti uscirono per strada ed Antonino, sfogò la rabbia repressa , mettendo il fez sulla testa del maiale e lasciando in casa a grufolare, ma la sera era calda e la porta era aperta. Il suino scappò prendendo la via della Fontana, per refrigerarsi. Fu inseguito dalle figlie che urlavano e ridevano, come fosse un gioco. Antonino non fece in tempo a riprendere il porco, che udì un sparo sordo e delle urla di giubilo, seguite da un rantolo animalesco. Quattro giovinastri coi baschi ornati da una stella e fazzoletti rossi intorno al collo si facevano fotografare, fucili alla mano, sul corpo inerme del povero maiale, il quale aveva ancora legato sulla testa il fez dei balilla. Antonino disperato corse verso di loro ma fu preso a calci. “Cosa fai?” Gli urlò quello che sembrava essere il più alto in grado “Questo e’ un maiale fascista, ed è il nostro bottino di guerra!” “Ma quale bottino di guerra” Rispose piangendo Antonino “Quello è il mio maiale!” . “Da oggi, comanda il popolo!” Gridarono in coro i miliziani “Tutto quello che hai lo devi dividere con il popolo che noi rappresentiamo” Detto questo presero il suino e lo caricarono sulla camionetta che portava dipinta sulla sponda la sigla CLN. Guardando allontanarsi l’autocarro, con la testa penzoloni del suo porco, Antonino, girò lo sguardo verso il cielo all’imbrunire e disse laconico: “Tutto sommato, Benito, non era poi una così brutta bestia!”