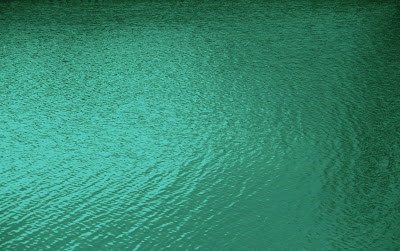La lepre inerme
sull’asfalto.
L’occhio vitreo
osservavo pietoso
se consumare frutto del delitto.
Decisi di lasciarla
con rimpianto.
Sognando per giorni
lo stesso misfatto
ed un salmì perfetto.
Morte di una nazione
 Quando ho iniziato a prendere coscienza del paese in cui sono nato, è stato molto presto. Avevo cinque anni ed abitavo a Milano. Spesso accompagnavo mia zia all’Università Statale. Era il 1973. Ricordo gli scontri tra manifestanti, i lacrimogeni. Ci buttavamo a terra per evitare le cariche. Ricordo la violenza della malavita, le rapine sotto casa , gli scippi, le aggressioni. Non sono immagini filmiche come le finzioni ridicole di Tarantino. Questo era un film italiano. Poi i “fantastici anni ’80”, quelli del disimpegno, il vero principio del declino italiano. Tutto leggerezza, fashion, allure, brand, accounting, launch, branch, creative manager, mercial banking, senior consulting. Infine i novanta delle tangenti o ” della scoperta dell’acqua calda”. In tutto questo caos di figliocci di operai che diventavano dirigenti di partito, amici dei manager, dove gli operai annoiati, diventavano sindacalisti e poi sindaci, la Mafia, silente, con qualche alzatina di voce, ha mandato i suoi figli all’Università al nord, a sciacquare soldi in palazzi e finanziarie. Meglio non far casino, va tutto bene in superficie, basta dare in pasto al popolo promesse di benessere, concessione di somigliare ai ricchi andandoli a binocolare a Porto Cervo. Il popolo si è addormentato piano, ma si è addormentato. Ho avuto sempre il senso della memoria, il capire che quello che stavo vedendo da bambino, lo avrei nitidamente ricordato ed interpretato, da grande. Ho vissuto, ascoltando leggendo, decifrando le parole delle persone, intuendo gli avvenimenti, esaminandoli, come fossi un adulto, nel corpo di un uomo che cresceva con gli anni. Ora quell’uomo già grande per osservare, è stato raggiunto dall’uomo che sono fuori, un quarantenne. Queste due persone si uniscono finalmente. Quello che vedo ha finito ormai, di preoccuparmi, di angosciarmi, di indignarmi. Ho raggiunto un pericoloso punto di non ritorno, come quando un minatore che è stato in miniera per vent’anni, non tossisce più inalando un gas tossico. La caduta del mio paese verso il baratro del nulla culturale, istituzionale, politico, del quale non mi sento assolutamente responsabile come cittadino, è tanto catastrofica da sembrare priva di conseguenze. Gli ultimi avvenimenti, sebbene un dettaglio, all’interno di una situazione generale irrecuperabile, sono sintomatici del clima di nuovo Medioevo post industriale: un misto di terrorismo religioso, unito a ritualità pagane, mediato da profonda ignoranza, grettezza morale, perdita di dignità. Siamo diventati dei cavernicoli digitalizzati, dei bigotti che aizzano figle adolescento con tette rifatte, siamo mariti e mogli di bodrille e grossisti di carni col Suv, di quelli che vanno con le puttane ucraine ed hanno la foto del papa in camera. L’aspetto peggiore è quello del mondo giornalistico. Chi legge tra le notizie, può capire quanto servilismo al potere, alla chiesa si nasconda dietro le notizie che inneggiano al pietismo peloso, alla sacralità della vita, alla moralità dei guardoni e di chi si fa guardare, con la scusa di essere richiesto dal popolo. Quanto anonimato ci sia , per le figure degne di considerazione e rispetto e quanto invece, lo stupro diventi viatico per una esposizione massmediatica con richiesta di relativo cachet. Tutti hanno fretta, tutti fanno cose più importanti degli altri: lo capisci quando sei l’unico ad inchiodare la macchina davanti le strisce pedonali. Ci hanno insegnato ad odiare il voto, lo hanno svuotato come il guscio di una cozza, non perdendo un briciolo del loro potere di delega. Così i vecchi insegnano ai discepoli che bravura è coglionaggine, furbizia è sopravvivenza. Quando penso all’Italia tra qualche anno, mi sembra di rivedere un film di Mel Gibson di quasi 25 anni fa: Mad Max, oppure di leggere un libro di Terzani sulla caduta dell’Impero sovietico: Buona notte Signor Lenin. Un’Italia balcanizzata, una Sarajevo, dove la guerra non è mai avvenuta, ma la distruzione si è propagata per implosione. Branchi di italiani affamati, armati, lottano per la sopravvivenza saccheggiando campagne, uccidendo, mentre contadini si difendono, con barricate. Paesi con il coprifuoco, dove gli estranei vengono catturati e giustiziati sommariamente, bambini abbandonati ai cigli delle strade, nel ricordo delle fotografie dei piccoli ebrei a Varsavia durante la guerra. La narcosi elettronica non ci fa leggere il futuro. L’uomo cresciuto dentro di me, ricorda, mi parla. Riesco a capire e faccio finta di niente…
Quando ho iniziato a prendere coscienza del paese in cui sono nato, è stato molto presto. Avevo cinque anni ed abitavo a Milano. Spesso accompagnavo mia zia all’Università Statale. Era il 1973. Ricordo gli scontri tra manifestanti, i lacrimogeni. Ci buttavamo a terra per evitare le cariche. Ricordo la violenza della malavita, le rapine sotto casa , gli scippi, le aggressioni. Non sono immagini filmiche come le finzioni ridicole di Tarantino. Questo era un film italiano. Poi i “fantastici anni ’80”, quelli del disimpegno, il vero principio del declino italiano. Tutto leggerezza, fashion, allure, brand, accounting, launch, branch, creative manager, mercial banking, senior consulting. Infine i novanta delle tangenti o ” della scoperta dell’acqua calda”. In tutto questo caos di figliocci di operai che diventavano dirigenti di partito, amici dei manager, dove gli operai annoiati, diventavano sindacalisti e poi sindaci, la Mafia, silente, con qualche alzatina di voce, ha mandato i suoi figli all’Università al nord, a sciacquare soldi in palazzi e finanziarie. Meglio non far casino, va tutto bene in superficie, basta dare in pasto al popolo promesse di benessere, concessione di somigliare ai ricchi andandoli a binocolare a Porto Cervo. Il popolo si è addormentato piano, ma si è addormentato. Ho avuto sempre il senso della memoria, il capire che quello che stavo vedendo da bambino, lo avrei nitidamente ricordato ed interpretato, da grande. Ho vissuto, ascoltando leggendo, decifrando le parole delle persone, intuendo gli avvenimenti, esaminandoli, come fossi un adulto, nel corpo di un uomo che cresceva con gli anni. Ora quell’uomo già grande per osservare, è stato raggiunto dall’uomo che sono fuori, un quarantenne. Queste due persone si uniscono finalmente. Quello che vedo ha finito ormai, di preoccuparmi, di angosciarmi, di indignarmi. Ho raggiunto un pericoloso punto di non ritorno, come quando un minatore che è stato in miniera per vent’anni, non tossisce più inalando un gas tossico. La caduta del mio paese verso il baratro del nulla culturale, istituzionale, politico, del quale non mi sento assolutamente responsabile come cittadino, è tanto catastrofica da sembrare priva di conseguenze. Gli ultimi avvenimenti, sebbene un dettaglio, all’interno di una situazione generale irrecuperabile, sono sintomatici del clima di nuovo Medioevo post industriale: un misto di terrorismo religioso, unito a ritualità pagane, mediato da profonda ignoranza, grettezza morale, perdita di dignità. Siamo diventati dei cavernicoli digitalizzati, dei bigotti che aizzano figle adolescento con tette rifatte, siamo mariti e mogli di bodrille e grossisti di carni col Suv, di quelli che vanno con le puttane ucraine ed hanno la foto del papa in camera. L’aspetto peggiore è quello del mondo giornalistico. Chi legge tra le notizie, può capire quanto servilismo al potere, alla chiesa si nasconda dietro le notizie che inneggiano al pietismo peloso, alla sacralità della vita, alla moralità dei guardoni e di chi si fa guardare, con la scusa di essere richiesto dal popolo. Quanto anonimato ci sia , per le figure degne di considerazione e rispetto e quanto invece, lo stupro diventi viatico per una esposizione massmediatica con richiesta di relativo cachet. Tutti hanno fretta, tutti fanno cose più importanti degli altri: lo capisci quando sei l’unico ad inchiodare la macchina davanti le strisce pedonali. Ci hanno insegnato ad odiare il voto, lo hanno svuotato come il guscio di una cozza, non perdendo un briciolo del loro potere di delega. Così i vecchi insegnano ai discepoli che bravura è coglionaggine, furbizia è sopravvivenza. Quando penso all’Italia tra qualche anno, mi sembra di rivedere un film di Mel Gibson di quasi 25 anni fa: Mad Max, oppure di leggere un libro di Terzani sulla caduta dell’Impero sovietico: Buona notte Signor Lenin. Un’Italia balcanizzata, una Sarajevo, dove la guerra non è mai avvenuta, ma la distruzione si è propagata per implosione. Branchi di italiani affamati, armati, lottano per la sopravvivenza saccheggiando campagne, uccidendo, mentre contadini si difendono, con barricate. Paesi con il coprifuoco, dove gli estranei vengono catturati e giustiziati sommariamente, bambini abbandonati ai cigli delle strade, nel ricordo delle fotografie dei piccoli ebrei a Varsavia durante la guerra. La narcosi elettronica non ci fa leggere il futuro. L’uomo cresciuto dentro di me, ricorda, mi parla. Riesco a capire e faccio finta di niente…
Sognomorfina numero 1
The Autobus figure of shit

Novembre 1987
L`autobus che mi conduce da L`Aquila a Pescara risulta talvolta interessante a causa delle vicende su di esso accadute. Spesso non per mia volontà ma per un fato voluto dagli dei immortali. Passare per maniaco non e` mai stato uno dei miei sogni, ma l`opportunità di scrivere questo racconto, grazie a questo epiteto per un giorno, mi riempie di nostalgica commozione, manco fossi Pacciani. Mi trovo in una fredda sera di novembre, al ritorno verso la città universitaria. Sull`autobus, un vecchio Iveco azzurro dell`Arpa, dagli interni intrisi di odore di mozziconi, panini con la frittata e scoregge, vi sono pochi pendolari, qualche mesto forforoso cinquantenne impiegato in banca, un controllore con la panza causata da un eccesso di tacchino alla canzanese e fermentato, due racchie che hanno ricacciato il cappotto dall`armadio ai primi geli, il cui odore di antitarme è un ulteriore deterrente a qualsiasi approccio maschile. Mi siedo, come ogni giovane si rispetti, ha il dovere di fare, sui sedili retrostanti. Tra me e gli altri passeggeri, molte file di poltroncine vuote. Pregusto la serata tranquilla. Ho il walkman con un paio di cose dei Nuclear Assault e degli Omen, a me i Nuclear piacciono di più degli Anthrax e poi Dan Lilker e` l`eroe indiscusso dei SOD. All`altezza di Brecciarola, sale una formosa pulzella , dalla gonna attillata e dalle tette abbastanza gonfie da suscitare serotine erezioni nei giovani studenti. Si va a sedere davanti a me, lasciando tra noi l`intervallo di un posto vuoto. Nella semioscurità della luce azzurrognola emanata dai lampioncini dell`autobus, la pulza si rannicchia sul suo sedile per dormire, sporgendo pericolosamente le rotondità del suo bel culo, lungo il corridoio del mezzo. La gonna appositamente cucita per esaltare le curve gluteesche, e` leggermente sollevata, lasciando intravvedere un paio di slip da lap dancer. I miei occhi inadatti perfino alla guida diurna con lenti, si trasformano in raggi laser della ditta Same-Govj, di quelli che trovi in offerta sulle ultime pagine del “Monello” o di “Cronaca Vera”. Parte una sega mentale addolcita dall`ammortizzatore lungo del vecchio bus. Nel mezzo di questa onirica pippa, sale un uomo che si va immediatamente a sedere tra me e la giovane. Nessuno dei passeggeri che si trovano avanti, si gira a vedere il nostro trittico in fila indiana. Solo il controllore fa una passata per i biglietti, senza dire una parola. L`uomo davanti a me e` un bruno butterato con la faccia ai frutti di mare, sembra Bukowski giovane. Con il controllore, caccia una vocina tipo cattivo di Roger Rabbit, cosa totalmente inadatta al suo aspetto da pedofilo serial killer. Ha sicuramente fumato delle N80, alla fermata. Le N80 sono delle nazionali con filtro, caratterizzate da un sapore ed un odore dolciastro e persistente, che riesce ad attaccare le ghiandole sebacee della pelle di chi le fuma, trasformandolo in un posacenere lavato male. Nocive per il fisico e per i rapporti sociali, sono da preferire alle Lido blu o alle John Player Special, quest`ultima sigaretta considerata forse la sublimazione dell`essenza di una discarica di calzini sudati dell`esercito. Il giovane mi indispone, la sua presenza olezzante e lasciva, mi impedisce la visione culistica della pulzella. Mi addormento , nonostante il walkman con i Nuclear sia a palla. Nel torpore della sonnolenza metallica realizzo una voce di donna che recrimina ad alta voce: “ Levami le mani di dosso, porco!”. Mi sveglio di soprassalto e vedo la scena: Il maiale butterato non ha resistito al richiamo del culo giovanile, a differenza del sottoscritto, ha aderito al motto “pensiero ed azione”, allungando il suo nodoso arto tra i glutei della giovane, fino ad arrivare al vistoso rigonfiamento della topa, pinzando sagacemente e prontamente il morbido frutto. La giovane, al tatto, si e` svegliata di colpo, serrando le cosce, imprigionando le mani dell`attentatore, il quale lieto della nuova posizione raggiunta, ha iniziato a ritrarre ritmicamente la mano, sperando in un cambiamento di umore della pulza. La ragazza si alza di colpo e si rifugia tra le braccia del corpulento bigliettaio, il quale sopraggiunto nel frattempo, ha solo modo di dire: “che le sta dando fastidio, signorina?”, accompagnandola poi, tra i sedili dei primi posti. Rimaniamo dietro io ed il maniaco, con il principio di uccello infiammato. Secondo le leggi della figura di merda, chi la fa, si guarda bene dall`esporsi in pubblico subito dopo. Ma ci sono delle varianti che non vengono considerate. Chi Pratica spesso la figura di merda, conosce i metodi per uscirne alla grande. Poco dopo, infatti, il maneggiatore, forte del fatto che nessun passeggero si era girato a veder la scena di palpamento, si alza e si va a sedere davanti, vicino agli altri.. In quel momento si insinua in me una leggerissima preoccupazione. E` successo un fattaccio nelle retrovie, eravamo in tre, nessun testimone, sono rimasto da solo agli ultimi posti, sono io il colpevole. Verso la piana di Navelli, infatti, i passeggeri che prima avevano solo ascoltato la concitata richiesta di aiuto della pulzella, senza girarsi a veder chi fosse il bruto, iniziano a prendere coraggio e nella semioscurità li vedo girarsi verso il retro del bus, ad inquadrare l`unico passeggero, cioè io. Ad una iniziale ricognizione visiva da parte di tutti i passeggeri a turno, inizia il terrore della “figure of shit”, che mi attacca le membra, ghiacciandomi la schiena. Incominciano le guardate secondarie. C`e` una matura zitellona , più brutta del cruscotto di una Innocenti, che si gira scuotendo il capo con espressione di disappunto. Il tutto contornato da una maligna omertà del controllore, unico vero testimone, capace di scagionarmi da questo terribile equivoco. Raggiungo il top dell`orrore, qualcosa di simile alle ultime frasi dei racconti di Poe, quando anche il maniaco, in un atto sublime della sua tecnica, probabilmente adottata con successo su altri mezzi pubblici, si gira anche lui apostrofandomi con mugugni tipo, “ah, che roba” oppure “che tempi”. Sono alla frutta. Dovrei scendere al Torrione ma mi trovo a Collemaggio. Suono il campanello, Mi viene aperta, Forca Caudina, solo la portiera anteriore. Sarò costretto a passare in mezzo a tutta quella gente…No! Chiudo gli occhi tra le offese ed i rimproveri generali, esco, perdendomi nella notte. Solo un bastardo butterato, si gira salutandomi attraverso il vetro, con la mano ed un sorriso luciferino tra i denti d`oro.
San Biagio
 San Biagio Il Santo protettore della gola
San Biagio Il Santo protettore della gola
a protezione degli stragajjune
Sande Bbièesce tenè nove fratielle.
Da nove ha ‘rmaste a òtte:
da òtte ha ‘rmaste a ssette:
da sette ha ‘rmaste a ssiè:
da siè ha ‘rmaste a cinghe:
da cinghe ha ‘rmaste a quattre:
da quattre ha ‘rmaste a ttre:
da tre ha ‘rmaste a ddù:
da ddù ha ‘rmaste a une.
Sande Bbièsce, squajje ste gaiiune!
J’ te segne + e Ddijje t’arsène
Sabbia
Un sudore strizzato, sabbioso, acre, gli appiccicava la divisa lungo la schiena. Camillo era stato tutto il giorno al telegrafo. Correva, la strisciolina di carta, ora un tratto, ora due punti. Arrivava ad intrecciare gli occhi. Avvezzo alla traduzione, Camillo leggeva dispacci, trasformava comandi, informazioni, notizie. Erano a pochi chilometri da Addis Abeba. Sotto una lampadina flebile, dalla luce sinistra, interrotta dai lampi diurni di una tenda che si apre e che fa entrare il deserto a scartavetrarti la gola, stava, mio nonno alla fine del suo turno. Si alzò dalla sedia brontolando e si stese sulla branda, lasciando il posto al compagno. Una vecchia copia della Domenica del Corriere, ingiallita dal passaggio di mani, era l’unico diversivo ai notturni silenzi del deserto. “Chi cazzo sono questi Ascari?”, fece Camillo, novello Don Abbondio alle prese con Carneade. Girò le pagine distrattamente fino a quella dove, una vecchia stampa d’epoca, ritraeva il Barone Ricasoli, sotto le sue vigne. Il pensiero andò ai genitori, a Pennadomo, al padre Nicola, anche lui stava rientrando dalla vigna. Lo vedeva risalire le scalette sotto al paese, portandosi dietro Rosina, l’asina, carica di verdura e legna. La coppoletta calata sulla testa e il mezzo toscano spento, in bocca. Quella sera c’erano le prove con la banda e nonnò mormorava la sua parte di bombardino, tra i denti. Camillo vedeva il padre fermarsi davanti la porta dell’osteria, sulla piazzetta Orientale. Il rumore dei ferri di Rosina sarebbe bastato a far uscire nonn’Anna dalla porta, nonno Nicola non consumava più di due parole con lei. Sulla porta dell’osteria c’erano due fraschette con una bottiglia vuota, a significare che lì si beveva.
“Chi ci stà dentro?” avrebbe chiesto come al solito nonno Nicola. Se nonn’Anna parlava, erano amici e quindi nonno Nicola le avrebbe comandato di prendere “il vino” tirando nervosamente il capo da un lato, se nonn’Anna non parlava ma accennava ad un gesto enigmatico, erano stranieri e quindi sarebbe stato nonno a prendere il vino. Fatto questo nonn’Anna sarebbe rientrata in osteria e nonno sarebbe sceso a rimettere Rosina alla stalla, poi, si sarebbe recato in cantina, dove c’era la vecchia botte di castagno, piena di vino che aveva preso la via dell’aceto. Mentre nonno riempiva la bottiglia, con una smorfia di disappunto per tutto quel ben di Dio rovinato, nonn’Anna intanto, portava subito un bel piatto di finocchi, per addormentare la bocca degli avventori. Nonno risaliva con la bottiglia di vino in mano ed un flebile sorriso da figlio di puttana, sotto i baffi. Camillo steso sulla branda, rise ad alta voce, come se un telone di cinema gli avesse riproposto la scena sotto gli occhi. Si girò il compagno, con uno scatto di sorpresa, ad interrompere il monotono ticchettio della trasmittente: “Camì, che minchia ti ridi?”. Ma Camillo non rispondeva più, dormiva con l’ultimo pensiero per Adele…
In quei giorni al campo c’era stato grande fermento: durante una battuta di perlustrazione era stato ritrovato un campo di italiani, caduti durante un’imboscata; tra le vittime vi era un fotografo. I nemici non avevano toccato le sue attrezzature, limitandosi a saccheggiare solo viveri e ciondoli. Tra i compagni di Camillo c’era uno di Varese, che nella vita borghese, faceva l’aiuto fotografo in un grande studio della città. La compagnia di Camillo era accampata vicino al villaggio della loro guida, un negrone alto e statuario che sembrava quasi un Masai. Stavano in un posto tranquillo e c’era tutto il tempo di cazzeggiare con l’attrezzatura fotografica. Iniziarono a sviluppare vetrini ed a stampare, quello che la vittima aveva involontariamente lasciato loro in eredità. Scoprirono che il fotografo ucciso, era un sorta di etnologo, che stava effettuando studi sulle popolazioni ribelli della regione. Si era accodato ad una compagnia in avanscoperta, con la speranza di essere al sicuro, ma aveva trovato una dolorosa morte, sotto la lama di una banda di predoni, in attività, durante quei confusi giorni di guerra. Camillo aiutava volentieri il fotografo di Varese, anche perché era un bel modo di passare i momenti di riposo. Fu grande lo stupore, quindi, al constatare che una serie di negativi erano dedicati esclusivamente al Negus. Lo avevano immortalato in tutte le pose: impugnando un mitragliatore, al comando di soldati sul cammello, in piedi, sopra un cumulo di cadaveri di ribelli.
La buonanima del fotografo, aveva anche lasciato loro, una serie di vetrini vergini. Pensarono immediatamente di utilizzarli, per fare fotografie a tutta la compagnia. Il sottotenente, che si dilettava a dipingere, creò uno sfondo con un vecchio lenzuolo. Due reclute mantenevano il lenzuolo e, a turno, ogni soldato si faceva fotografare in divisa. Camillo e gli altri avevano notato che la zona tra le loro tende ed il villaggio, dopo i primi giorni, di diffidenza, si era animata. All’inizio si erano avvicinati i bambini, poi qualche vecchio, alla fine delle ragazze. Si mantenevano sempre a debita distanza, ma erano curiose di vedere quegli uomini, simili nei sorrisi ai loro giovani, ma bianchi, in divisa, sempre indaffarati a fare qualcosa di cui loro non capivano il significato. Erano delle bellezze che Camillo non aveva mai visto. Nascosti i loro corpi a malapena, da piccoli reggiseni di pelle e gonne formate da fili di piante, simili a stuoie di paglia, il nero della loro pelle, colpito dai raggi del sole, creava riflessi morbidi, come se la luce avesse rischiarato le rocce scure e bagnate di un torrente. Camillo, aveva visto, fino ad allora, Adele, ma l’aveva vista rigorosamente vestita. La figlia della speziale, portava quei lunghi vestiti, incorniciati dai pizzi che lei stessa faceva, con quelle pettinature scolpite fra fermagli d’osso. Cipria e rossetto, sugli incarnati di madreperla ad esternare tremebondi e vulnerabili pudori, a chiudere fortezze facilmente espugnabili, in qualche bosco estivo vicino al Sangro. Pensando ad Adele, Camillo era inebriato da tanto innocente scoprirsi delle carni, da parte delle ragazze del villaggio. Comprendeva la naturalezza dell’appartenere alla terra ed allo stesso tempo era combattuto dalle visioni di riti ancestrali, veli e statue in processione, della sua terra d’Abruzzo. Ma aveva quasi vent’anni. Erano lontani da casa. Le fidanzate, le madri, le promesse spose, erano lontane mille e mille miglia. Anche Adele, quasi avesse potuto avere un cannocchiale per veder quello che Camillo poteva combinare.
Le ragazze del paese si avvicinavano ogni giorno di più, allontanando il senso del peccato ogni giorno di più. Fino a quando, un giorno, il varesino trovò il modo di avvicinare le fanciulle e chieder loro di scattare qualche foto. Fu un tripudio di gioia e risate. Furono fotografie di giovani a torso nudo che abbracciavano ridendo, quelle sculture eburnee e generose. Camillo dimenticò Pennadomo, voleva eliminarla, nel tremore dei sensi che si svegliavano, che esplodevano, che fiaccavano le notti dei soldati. Voleva odorare corpi nuovi, bocche, tastare membra che aveva visto solo in qualche volume di Salgari. Quella notte…
Era una giovane, figlia di un vecchio cacciatore del villaggio. I silenzi della distesa africana, erano interrotti solo, da qualche colpo di artiglieria lontano. Girava ancora inebriato dai brindisi a base di pessimi distillati, trovati nella dispensa. La ragazza lo aspettava. Lo prese per mano. Era frastornato, eccitato, si lasciò andare. Guardava la luce nitida della luna africana, illuminare il nero di quelle gambe, come di pece che lo tenevano stretto, senza dire parole, perché non sarebbero servite. I seni della ragazza, si puntavano sul suo petto. Conobbe un amore, il solo, disinteressato, libero, senza domani, senza religioni, né rimorsi. Rimasero le foto. Le aveva nel cassetto della sua vecchiaia.
La vicina

La vicina aveva un culo che tendeva i pantaloni come un pallone da calcio. E poi, vestiva così strano. Quei piercing, anche sull’ombelico sempre in vista e quel tatuaggio… Le partiva di traverso sulla pancia e le andava a finire sotto la cintura, in direzione del pube. Tommaso immaginava dove si fermava quella strana scritta e avrebbe tanto desiderato leggerla ad alta voce. La ragazza era una tossica. Nessuno avrebbe potuto sospettarlo, data la floridezza del soggetto. Nessuno sapeva, neanche i suoi, che avesse la Malattia. Solo Tommaso lo sapeva, ma lo nascondeva sotto quell’ aspetto segaligno e freddo. Un giorno, era venuta per un esame, nel laboratorio in cui Tommaso lavorava e lui, da curioso, aveva voluto indagare sulla ragazza. Un po’ come fanno i fotografi, quando qualcuno gli porta da sviluppare un rullino. Si mettono a sbirciare le fotografie e invadono le vite degli altri. Così, sapendo, le passava davanti, salutandola freddamente, mantenendo quell’aria scandalizzata, perfetta per un mediocre come lui. Ma se lei avesse conosciuto veramente Tommaso, sarebbe scappata in casa, serrando a porta due mandate…l Tommaso era un satanista. Di quelli peggiori. Peggiori come possono essere quelli che nella vita comune, sono i più anonimi ed i più inquadrati. La sua passione per il satanismo acido era passata ed ora si stava spingendo verso un gioco pericoloso, senza ritorno. Avevano iniziato con le orge, lui e gli altri. Ogni tanto sgozzavano qualche gallina. Ma più che drogarsi e praticare sodomia, non andavano. Poi era arrivato il Maestro. Avevano raddoppiato l’intensità degli incontri e c’ era scappato il primo morto. Una puttana. Prelevata con la scusa di un servizietto, narcotizzata e portata sul luogo del Sabba in stato di semincoscienza. Il fatto è che la troia aveva pensato bene di svegliarsi durante la violenza di gruppo e il Maestro le aveva tappato la bocca con uno straccio. Aveva esagerato. Era morta soffocata. Tutti erano colpevoli. Il Maestro aveva proferito minacce terribili se qualcuno avesse parlato. In ogni caso fu semplice liberarsi del corpo. C’ era una conceria vicino e quelle vasche piene di acido svolsero un bel lavoro. Eliminato l’oggetto del delitto, Tommaso eliminò il crimine commesso dalla sua coscienza, dato che ne avesse ancora una. Così, sazio di sparizioni, non si accorse che la vicina non si vedeva da qualche giorno. Ma era sabato. La sera dell’incontro. Erano in circolo, attorno all’altare, dove giaceva la vittima. Tommaso non riusciva a distinguere bene intorno a se. Aveva preso una dose eccessiva e non aveva gli occhiali, quei grossi, stupidi occhiali a culo di bottiglia. In un attimo furono tutti addosso alla vittima. Nella nebbia della sua trance, Tommaso riuscì a capire che la vittima era una donna, come al solito. Ma il fatto strano è che fosse consenziente. Tommaso riuscì a prenderla da dietro. La sodomizzò. Spingeva più delle altre volte, tanto che sentì qualcosa di suo lacerarsi. Come una puntura alla base del suo membro. La teneva da dietro , tirandola per le spalle. Davanti alla donna due uomini si facevano masturbare. Tommaso godeva. Era un misto tra l’effetto della droga e l’orgasmo. Sentiva solo il freddo marmo dell’altare, premere sulle sue ginocchia. Venne e istintivamente nella penombra, girò la donna incappucciata verso di se. L’unica cosa che riuscì a leggere, prima di ficcarsi il coltello in gola, fu la fine di quel tatuaggio sul pube…
Vetro
La strada della memoria
Gianluca Di Renzo